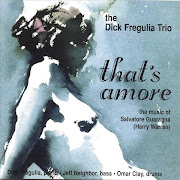Benvenuto sul Sito Internet del Comune di Tarsia
In questa sezione potrai consultare: Storia | Da Visitare | Eventi | Informazioni
Sei nella pagina: Tarsia \ Storia \ Ferramonti
La costruzione, del Campo di concentramento di Ferramonti di Tarsia, ha avuto inizio nel maggio 1940 ed è stata eseguita dalla ditta Parrini di Roma; alla stessa è stata affidata successivamente la manutenzione di tutto il Campo.
Il Campo, a differenza degli altri Campi di Concentramento italiani fu costruito ad hoc, e, nell'aspetto esteriore ricordava chiaramente un lager nazista, fatto com'era da lunghi capannoni e posto nell'immediata vicinanza della linea ferroviaria Sibari-Cosenza.
È stato il più grande ed importante Campo di Concentramento fascista Italiano, con una presenza media di oltre 2000 persone ed una punta massima, raggiunta nell'estate 1943, di 2.700 persone.
Era costituito da 92 baracche su un territorio di circa mq. 160.000 circondato da un recinto di filo spinato, sorvegliato dall'esterno lungo il suo perimetro dalla Milizia Fascista (gente del luogo e dei paesi vicini), mentre all'interno era sorvegliato da un Commissariato di Pubblica Sicurezza alle cui dipendenze vi erano un gruppo di agenti ed un Maresciallo.
Il Campo sorgeva nella Valle del Fiume Crati, a circa 6 Km dal paese di TARSIA, in una zona malsana, malarica e paludosa, dove erano in corso lavori di bonifica. Durante il periodo di prigionia molti internati si ammalarono e morirono di malaria. Esso entrò ufficialmente in funzione il 20 Giugno 1940.
Tra la fine di giugno e luglio 1940, giunsero a Ferramonti, provenienti da varie città dell'Italia Centro-settentrionale, più di un centinaio di Ebrei, solo uomini. Giorno dopo giorno arrivarono centinaia di persone così da formare, all'interno del Campo, una varietà di culture, lingue e usanze, ma dando anche luogo a non poche difficoltà dovute all'eccessiva popolazione ed alle ristrettezze economiche.
Dall'autunno del 1941 gli internati di Ferramonti non furono più soltanto Ebrei, Dalla Jugoslavia occupata, cominciarono ad arrivare moltissimi internati ariani, uomini politici e semplici cittadini che avevano avuto contatti con i partigiani.
Nel novembre 1941 arrivarono a Ferramonti i primi nuclei di Cinesi, altri profughi fuggiti dai Campi di concentramento della Germania e della Polonia giunsero da Rodi, si trattava per lo più di Ungheresi imbarcatisi a Bratislava, il 16 Maggio 1940 sul "Pentcho".
Gli internati arrivarono a Ferramonti sempre ammanettati, accompagnati da Carabinieri, venivano fatti scendere alla stazione ferroviaria della vicina Mongrassano e da qui proseguivano a piedi per circa 6 Km. Alcune volte, venivano fatti scendere direttamente al Casello Ferroviario di Ferramonti, a pochi metri dall'ingresso del Campo.
Il primo Commissario di P.S., nominato dal Ministero degli Interni a dirigere il campo fu Paolo SALVATORE.
Il 10 Luglio la Direzione del campo, rese noto il regolamento disciplinare a cui dovevano attenersi gli internati, che, riportava quanto previsto dalla Circolare ministeriale n. 442/12267, emanata l'8 giugno 1940 ed avente ad oggetto la prescrizione per i campi di concentramento e le località di confino.
Sottoposti a 3 appelli giornalieri, gli internati non potevano uscire dalle baracche prima delle 7.00 e dopo le 21.00, o superare i limiti del Campo senza uno speciale lasciapassare. Non potevano occuparsi di politica, né leggere, senza autorizzazione, pubblicazioni estere e la corrispondenza. Pure proibiti erano la detenzione e l'uso di apparecchi fotografici e radiofoniche e di carte da gioco. Non era invece previsto l'obbligo di lavorare, chi non aveva altri redditi per il proprio mantenimento, riceveva un sussidio governativo.
Gli internati realizzarono ben presto una organizzazione interna a carattere democratico basato sull'elezione diretta di un delegato per ogni baracca. Essi si riunivano tutte le settimane in una sorta di Assemblea dei delegati delle baracche, che eleggeva al suo interno un rappresentante generale di tutti gli internati, il Capo dei Capi delle baracche. Il più prestigioso fu GIANNI MANN.
Il Direttore del campo riconosceva ufficiosamente l'esistenza degli organi di autogestione e si appoggiava volentieri ad essi per mantenere quella tranquillità necessaria specialmente con l'arrivo delle donne e dei bambini.
Con l'arrivo dei bambini sorsero nuovi problemi in ordine alle scarse capacità alimentari e all'istruzione. Un sostanziale aiuto venne dato dalla organizzazione di ISRAEL KALK.
Con il beneplacito del Ministero degli Interni e della direzione, l'ing. Kalk poté dare il suo sostegno materiale e morale in quei duri anni agli internati di Ferramonti.
Gestiti degli stessi internati funzionarono una scuola, un asilo, un ambulatorio medico e, inoltre, si svilupparono varie attività artistiche, culturali e religiose, sia ebraiche che cristiane.
Tra gli internati del Campo vi erano decine di medici, tre rabbini, illustri pittori e musicisti, numerosissimi insegnanti e studenti universitari. Ognuno cercava di svolgere varie attività. La scuola del campo, fondata nell'autunno del 1940 da ERICH WITTENBERG (profugo dalla Cecoslovacchia, che fu il primo direttore) si arricchì di nuovi corsi e fu affiancata da un asilo per i più piccoli. All'interno del Campo vennero aperte anche 3 Sinagoghe.
Il 22 Maggio 1941, il Campo di Ferramonti, veniva visitato dal Nunzio Apostolico presso il governo italiano, Monsignor Francesco BORGONCINI-DUCA.
In occasione della visita del Nunzio Apostolico, gli ebrei chiesero di avere a Ferramonti una continua assistenza spirituale. Due mesi dopo fu inviato nel Campo il Cappuccino sessantacinquenne Padre Calisto LOPINOT, che presto riuscì ad accattivarsi la stima anche degli internati non Cattolici.
Visitò più volte il Campo di Ferramonti il Rabbino Capo di Genova dottor Riccardo PACIFICI, il quale celebrò solenni cerimonie nel Campo. Frequenti le manifestazioni artistiche e dibattiti culturali a Ferramonti: la vita culturale fu particolarmente intensa se non altro perché al suo interno si trovarono riuniti molti artisti di talento, vennero organizzati spettacoli teatrali, mostre di arte, corsi per adulti, conferenze.
La vita musicale era curata dal Maestro LAV MIRSKI, che prima della guerra era stato direttore d'orchestra all'Opera di OSIJEK (Jugoslavia). Anche lo sport ebbe grande impulso e in esso primeggiò il calcio, molto seguiti erano i tornei di scacchi .
I numerosi medici internati, spesso, alla fine della guerra furono autorizzati a curare anche persone dei paesi vicini. Uno di essi, dopo la liberazione, si trasferì proprio nel paese di Tarsia, dove rimase per circa 1 anno; un altro impiantò lo studio a Castrovillari, una cittadina a circa 30 Km. da Tarsia.
Nel 1943 fin dal primo mese avvennero numerosi episodi che mutarono le condizioni all'interno del Campo. Il 22 Giugno 1943 il direttore del Campo Paolo SALVATORE, venne trasferito, fu sostituito nel ruolo da Mario FRATICELLI.
Nell'estate 1943 la malnutrizione e la fame erano ormai una consuetudine a Ferramonti. Giungevano nel Campo una nuova categoria di internati, gli antifascisti italiani trasferiti da altri luoghi di detenzione.
Il 25 luglio 1943, un telegramma del Sottosegretario di Stato, diretto al Capo della Polizia chiedeva il trasferimento degli internati di Ferramonti di Tarsia nella Provincia di Bolzano ad un tiro di schioppo dalla fortezza tedesca. Ma quel giorno la storia avrebbe riservato altri avvenimenti: MUSSOLINI venne deposto e gli internati, temporaneamente, furono salvi.
Il 14 Settembre del 1943, verso le otto del mattino, sulla strada di Ferramonti apparivano i carri dell'VIII Armata Britannica. La Liberazione di Ferramonti avvenne in modo del tutto imprevisto.
La maggior parte degli internati, anche dopo l'arrivo degli alleati, non sapendo esattamente dove andare e cosa fare rimase a Ferramonti o si trasferì nella vicina Cosenza. L'abbandono del Campo si è avuto solo alla fine della seconda guerra Mondiale con la liberazione di tutta l'Europa dal giogo nazi-fascista.
Successivamente all'abbandono completo, da parte degli internati, le baracche che erano ben tenute non vennero in alcun modo vigilate e così iniziarono veri e propri saccheggi che vennero completati alla fine degli anni ‘60 dai lavori autostradali (A3 SA/RC) che ha diviso e sventrato in due tronconi le baracche esistenti.
Oggi poco è rimasto: le uniche baracche sono quelle che, durante il funzionamento del Campo, erano state utilizzate dalla Direzione e dagli uffici dell'Amministrazione del Campo, grazie alla cura dei coniugi PETRONI, dipendenti della Ditta PARRINI, che vi dimorarono fino alla loro morte (primi anni '90).
Del Campo di Concentramento nessuno parlò fino alla metà degli anni ‘70. Il Prof. Franco FOLINO, professore di lettere della vicina Roggiano Gravina, alla luce dei racconti di cittadini che hanno vissuto personalmente quegli anni, ha voluto approfondire questi racconti regalando così il suo primo libro su Ferramonti.
Ma solo alla fine degli anni 80, le istituzioni cominciarono a rendersi veramente conto ed a conoscere di nuovo Ferramonti ex Campo di Concentramento.
Così negli anni ‘90 l'Amministrazione Comunale di Tarsia, ha iniziato a mettere in atto iniziative concrete tese a valorizzare il " patrimonio "Ferramonti, così si è resa protagonista di atti formali, quale appunto far sottoporre, in data 30/08/1999, l'area a vincolo da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e procedendo alla recinzione di tutto il terreno.
Avendo registrato grande interesse, soprattutto da parte delle scuole, e vista la poca sensibilità da parte delle istituzioni sovra-comunali, L'Amministrazione Comunale di Tarsia, in collaborazione con il Comitato PRO-FERRAMONTI, oggi Fondazione " Museo della Memoria Ferramonti di Tarsia ", ha voluto dare un segnale forte realizzando all'interno di una baracca, il Museo della Memoria, che, ripercorre, con documenti e fotografie, gli anni in cui il Campo di Ferramonti è rimasto attivo. Il tutto è stato interamente realizzato con finanziamenti Comunali.
Il Museo è stato inaugurato il 25 Aprile 2004 ed è gestito dalla " Fondazione Museo della Memoria Ferramonti di Tarsia ", di nuova costituzione.
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE:
• F. Folino: " Ferramonti un lager di Mussolini ", Editore Brenner, Cosenza 1985;
• C. S. Capogreco: " Ferramonti, la vita e gli uomini del più grande campo di concentramento fascista (1940-1945) ", Giustina, Firenze 1987;
• F. Folino: " Ebrei destinazione Calabria (1940-1943) ", Editore Sellerio, Palermo 1988;
• F. Folino: " Ferramonti? Un misfatto senza sconti ", Editore Brenner, Cosenza 2004.
Per qualsiasi informazione telefonare al n. 0981-951881.
il logo
Storia
* Notizie Storiche
* Uomini Illustri
* Ferramonti
Galleria Fotografica
* Luoghi e memorie
Il Comune
* Amministrazione e servizi
Contatti | Mappa del sito | Utilizzo del sito | Credits | ©2005 Comune di Tarsia









.jpg)