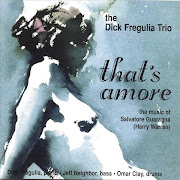PIEMME
Realizzazione editoriale: Conedit Libri Srl, Cormano (MI)
© 2010 by Pino Aprile
This book was negotiated through Ute Körner Literary Agent, S.L., Barcelona –
www.uklitag.com
I Edizione 2010
© 2010 - EDIZIONI PIEMME Spa
20145 Milano - Via Tiziano, 32
info@edizpiemme.it - www.edizpiemme.it
PINO APRILE
TERRONI
Diventare meridionali
Io non sapevo che i piemontesi fecero al Sud quello che i
nazisti fecero a Marzabotto. Ma tante volte, per anni.
E cancellarono per sempre molti paesi, in operazioni
“anti-terrorismo”, come i marines in Iraq.
Non sapevo che, nelle rappresaglie, si concessero libertà
di stupro sulle donne meridionali, come nei Balcani, durante
il conflitto etnico; o come i marocchini delle truppe
francesi, in Ciociaria, nell’invasione, da Sud, per redimere
l’Italia dal fascismo (ogni volta che viene liberato, il Mezzogiorno
ci rimette qualcosa).
Ignoravo che, in nome dell’Unità nazionale, i fratelli
d’Italia ebbero pure diritto di saccheggio delle città meridionali,
come i Lanzichenecchi a Roma.
E che praticarono la tortura, come i marines ad Abu
Ghraib, i francesi in Algeria, Pinochet in Cile.
Non sapevo che in Parlamento, a Torino, un deputato ex
garibaldino paragonò la ferocia e le stragi piemontesi al
Sud a quelle di «Tamerlano, Gengis Khan e Attila». Un altro
preferì tacere «rivelazioni di cui l’Europa potrebbe
inorridire». E Garibaldi parlò di «cose da cloaca».
Né che si incarcerarono i meridionali senza accusa, senza
processo e senza condanna, come è accaduto con gl’islamici
a Guantánamo. Lì qualche centinaio, terroristi per
definizione, perché musulmani; da noi centinaia di migliaia,
briganti per definizione, perché meridionali. E, se bambini,
briganti precoci; se donne, brigantesse o mogli, figlie, di briganti;
o consanguinei di briganti (sino al terzo grado di parentela);
o persino solo paesani o sospetti tali. Tutto a norma
di legge, si capisce, come in Sudafrica, con l’apartheid.
Io credevo che i briganti fossero proprio briganti, non
anche ex soldati borbonici e patrioti alla guerriglia per difendere
il proprio paese invaso.
Non sapevo che il paesaggio del Sud divenne come quello
del Kosovo, con fucilazioni in massa, fosse comuni, paesi
che bruciavano sulle colline e colonne di decine di migliaia
di profughi in marcia.
Non volevo credere che i primi campi di concentramento
e sterminio in Europa li istituirono gli italiani del Nord,
per tormentare e farvi morire gli italiani del Sud, a migliaia,
forse decine di migliaia (non si sa, perché li squagliavano
nella calce), come nell’Unione Sovietica di Stalin.
Ignoravo che il ministero degli Esteri dell’Italia unita
cercò per anni «una landa desolata», fra Patagonia, Borneo
e altri sperduti lidi, per deportarvi i meridionali e annientarli
lontano da occhi indiscreti.
Né sapevo che i fratelli d’Italia arrivati dal Nord svuotarono
le ricche banche meridionali, regge, musei, case private
(rubando persino le posate), per pagare i debiti del Piemonte
e costituire immensi patrimoni privati.
E mai avrei immaginato che i Mille fossero quasi tutti
avanzi di galera.
Non sapevo che, a Italia così unificata, imposero una tassa
aggiuntiva ai meridionali, per pagare le spese della guerra
di conquista del Sud, fatta senza nemmeno dichiararla.
Ignoravo che l’occupazione del Regno delle Due Sicilie
fosse stata decisa, progettata, protetta da Inghilterra e
Francia, e parzialmente finanziata dalla massoneria (detto
da Garibaldi, sino al gran maestro Armando Corona, nel
1988).
Né sapevo che il Regno delle Due Sicilie fosse, fino al
momento dell’aggressione, uno dei paesi più industrializzati
del mondo (terzo, dopo Inghilterra e Francia, prima di
essere invaso).
E non c’era la “burocrazia borbonica”, intesa quale caotica
e inefficiente: lo specialista inviato da Cavour nelle Due
Sicilie, per rimettervi ordine, riferì di un «mirabile organismo
finanziario» e propose di copiarla, in una relazione che
è «una lode sincera e continua». Mentre «il modello che
presiede alla nostra amministrazione», dal 1861, «è quello
franco-napoleonico, la cui versione sabauda è stata modulata
dall’unità in avanti in adesione a una miriade di pressioni
localistiche e corporative» (Marco Meriggi, Breve storia
dell’Italia settentrionale).
Ignoravo che lo stato unitario tassò ferocemente i milioni
di disperati meridionali che emigravano in America, per
assistere economicamente gli armatori delle navi che li trasportavano
e i settentrionali che andavano a “far la stagione”,
per qualche mese in Svizzera.
Non potevo immaginare che l’Italia unita facesse pagare
più tasse a chi stentava e moriva di malaria nelle caverne
dei Sassi di Matera, rispetto ai proprietari delle ville sul lago
di Como.
Avevo già esperienza delle ferrovie peggiori al Sud che al
Nord, ma non che, alle soglie del 2000, col resto d’Italia
percorso da treni ad alta velocità, il Mezzogiorno avesse
quasi mille chilometri di ferrovia in meno che prima della
Seconda guerra mondiale (7.958 contro 8.871), quasi sempre
ancora a binario unico e con gran parte della rete non
elettrificata.
Come potevo immaginare che stessimo così male, nell’inferno
dei Borbone, che per obbligarci a entrare nel paradiso
portatoci dai piemontesi ci vollero orribili rappresaglie,
stragi, una dozzina di anni di combattimenti, leggi
speciali, stati d’assedio, lager? E che, quando riuscirono a
farci smettere di preferire la morte al loro paradiso, sce-
gliemmo piuttosto di emigrare a milioni (e non era mai successo)?
Ignoravo che avrei dovuto studiare il francese, per apprendere
di essere italiano: «Le Royaume d’Italie est
aujourd’hui un fait» annunciò Cavour al Senato. «Le Roi notre
auguste Souverain prend pour lui-même et pour ses successeurs
le titre de Roi d’Italie.»
Credevo al Giosue Carducci delle Letture del Risorgimento
italiano: «Né mai unità di nazione fu fatta per aspirazione
di più grandi e pure intelligenze, né con sacrifici di più
nobili e sante anime, né con maggior libero consentimento
di tutte le parti sane del popolo». Affermazione riportata in
apertura del libro (Il Risorgimento italiano) distribuito gratuitamente
dai Centri di Lettura e Informazione a cura del
ministero della Pubblica Istruzione Direzione Generale per
l’Educazione Popolare, dal 1964. Il curatore, Alberto M.
Ghisalberti, avverte che, «a un secolo di distanza (...), la revisione
critica operata dagli storici possa suggerire interpretazioni
diversamente meditate (...) della più complessa
realtà del “libero consentimento” al quale si riferisce il
poeta». Chi sa, capisce; chi non sa, continua a non capire.
Scoprirò poi che Carducci, privatamente, scriveva: «A Lei
pare una bella cosa questa Italia?»; tanto che, per lui, evitare
di parlarne «può anche essere opera di carità». (Storia
d’Italia, Einaudi).
Io avevo sempre creduto ai libri di storia, alla leggenda
di Garibaldi.
Non sapevo nemmeno di essere meridionale, nel senso
che non avevo mai attribuito alcun valore, positivo o negativo,
al fatto di essere nato più a Sud o più a Nord di un altro.
Mi ritenevo solo fortunato a essere nato italiano. E fra
gl’italiani più fortunati, perché vivevo sul mare.
A mano a mano che scoprivo queste cose, ne parlavo. Io
stupito; gli ascoltatori increduli. Poi, io furioso; gli ascoltatori
seccati: esagerazioni, invenzioni e, se vere, cose vecchie.
E mi accorsi che diventavo meridionale, perché, stupidamente,
maturavo orgoglio per la geografia di cui, altrettanto
stupidamente, Bossi e complici volevano che mi vergognassi.
Loro che usano “italiano” come un insulto e
abitano la parte della penisola che fu denominata “Italia”,
quando Roma riorganizzò l’impero (quella meridionale
venne chiamata “Apulia”, dal nome della mia regione. Ma
la prima “Italia” della storia fu un pezzo di Calabria sul
Tirreno).
Si è scritto tanto sul Sud, ma non sembra sia servito a
molto, perché «ogni battaglia contro pregiudizi universalmente
condivisi è una battaglia persa» dice Nicholas
Humphrey (Una storia della mente). «Perché non riprendi
una delle tante pubblicazioni meridionaliste di venti,
trent’anni fa, e la ristampi tale e quale? Chi si accorgerebbe
che del tempo è passato, inutilmente?» suggeriva ottant’anni
fa a Piero Gobetti, Tommaso Fiore che poi, per
fortuna, scrisse Un popolo di formiche. E oggi, un economista
indomito, Gianfranco Viesti (Abolire il Mezzogiorno),
allarga le braccia: «Parlare di Mezzogiorno significa parlare
del già detto, e del già fallito».
Perché tale stato di cose è utile alla parte più forte del
paese, anche se si presenta con due nomi diversi: “Questione
meridionale”, ovvero dell’aspirazione del Sud a uscire
dalla subalternità impostagli; e “Questione settentrionale”,
di recente conio, ovvero della volontà del Nord di mantenere
la subalternità del Sud e il redditizio vantaggio di potere
conquistato con le armi e una legislazione squilibrata.
Dopo centocinquant’anni, questo sistema rischia di spezzare
il paese. Si sa; e si finge di non saperlo, perché troppi sono
gl’interessi che se ne nutrono.
Così, accade che la verità venga scritta, ma non sia letta;
e se letta, non creduta; e se creduta, non presa in considerazione;
e se presa in considerazione, non tanto da cambiare
i comportamenti, da indurre ad agire “di conseguenza”.
I meridionali si lamentano sempre e i carcerati si dicono
tutti innocenti. Il paragone non è casuale; nel bel libro Sull’identità
meridionale, Mario Alcaro scrive: «Si può dire
che è la difesa di un imputato, di un cittadino del Sud che
cerca una risposta alle tante critiche e accuse che gli son
piovute addosso». Il pregiudizio (pre, “prima”) è una condanna
senza processo. Sospetto che la sua persistenza eviti,
a chi lo nutre, un’ammissione di colpa. «L’uomo è un animale
mosso in modo determinante dalla colpa» rammenta
Luigi Zoja in Storia dell’arroganza. «Un sentimento di colpa
può essere spostato, non cancellato.» E il Nord aggressore
incolpa l’aggredito delle conseguenze dell’aggressione:
rimosso il rimorso, se mai c’è stato.
Noi meridionali conosciamo bene tutto questo: non ci
indigna nemmeno più; ci stanca: «Senti che la gente ti capisce
male, che devi parlare più forte, gridare» spiegava
Cˇechov. «E le grida sono ripugnanti. Parli a voce sempre
più bassa, forse tra poco tacerai del tutto.» Fra le urla dell’altro,
ormai privo del freno della vergogna che lo rendeva
civile.
Oggi, nuovi fermenti animano una ricerca di verità storica,
non solo meridionale, che viene dal basso, più che dalle
aule universitarie o dalla politica, dalle istituzioni. Non è facile
capire dove questo possa portare; se a un revanscismo
uguale e opposto al razzismo nordista di Lega e collaterali,
o a una comune crescita di consapevolezza e conoscenza:
un nuovo meridionalismo non solo meridionale (e sarebbe
un ritorno alle origini, perché nacque nordico, specie lombardo),
per ridare un’anima decente a un’Italia che l’ha
smarrita, nel fallimento della politica e la sua riduzione a furia
predatoria di egoismi personali e territoriali. Temo, per
il pessimismo della ragione e perché i segni vanno in quella
direzione, che il peggio prevalga, proprio “per” e non
“nonostante” i suoi difetti (è la legge di Greg e Galton, che
ricordo in Elogio dell’imbecille). Ma, per l’ottimismo della
volontà, spero nel contrario (nemmeno il peggio dura per
sempre; e anche i peggiori muoiono).
Il Nord, visto da Sud, è Caino: da lì vennero quelli che,
dicendosi fratelli, compirono al Sud, a scopo di rapina, il
massacro più imponente mai subito da queste regioni (e sì
che di barbari ne sono passati). I musei del Risorgimento,
nota Mario Isnenghi, nella sua Breve storia dell’Italia unita
a uso dei perplessi, sono quasi tutti al Centro o al Nord.
Il Nord è dove ho lavorato anni e ho amici, ed è casa mia;
come il Sud, dove sono nato; o il Centro, dove abito. Gl’italiani
vanno al Nord in cerca di soldi; al Sud in cerca dell’anima.
All’estero smettono di essere meridionali o settentrionali
e diventano solo italiani (indistintamente, nel
pregiudizio altrui, geni e farabutti).
Il Sud, visto da Nord, è L’inferno, titolo del libro di Giorgio
Bocca che nel 2008 ha scritto sul «Venerdì» di «Repubblica
», non so quanto provocatoriamente: «Sì, è vero, sono
un antimeridionale... Passo per razzista, e forse lo sono».
Nessuno vi trovò da ridire: è o no il Sud, nella geografia, anche
morale, il luogo del male? Del male senza possibilità di
redenzione: ché questo è l’inferno, congrua immagine del
«paradiso abitato da diavoli», secondo l’Alexandre Dumas
che accompagnò Garibaldi (e a che prezzo!) alla conquista
e al saccheggio.
Caino, al contrario, è un’espressione più saggia e attenta
alla verità, perché Caino non è perso per sempre, a differenza
di chi precipita all’inferno: gli viene offerta una possibilità
di riscatto, in un’altra terra. Anche se non la coglie.
Né pare vogliano farlo, oggi, tanti che ancora godono del
vantaggio ereditato da chi venne a sterminarci. Quando
scrivo “i settentrionali”, “i piemontesi”, non intendo generalizzare
(come avviene quando si parla di “meridionali”).
Alcuni dei più grandi meridionalisti erano del Nord; e gli
ascari che in Parlamento votano (dal 1861) contro l’equità
per le regioni che li hanno eletti, sono meridionali.
Il Sud è stato privato delle sue istituzioni; fu privato delle
sue industrie, della sua ricchezza, della capacità di reagire;
della sua gente (con una emigrazione indotta o forzata
senza pari in Europa); infine, con un’operazione di lobotomia
culturale, fu privato della consapevolezza di sé, della
memoria.
Noi non sappiamo più chi fummo. Ed è accaduto come
agli ebrei travolti dall’Olocausto (il paragone non è esagerato:
centinaia di migliaia, forse un milione di meridionali
furono sterminati dalle truppe sabaude; da tredici a oltre
venti milioni, secondo i conteggi, dovettero abbandonare la
loro terra, in un secolo): molti scampati ai lager cominciarono
a domandarsi se il male che li aveva investiti non fosse
in qualche modo meritato. Quando il danno è intollerabile,
cercare una colpa, pur assurda, inesistente, che lo
renda comprensibile (non giustificabile), diventa una via
per non perdere la ragione. Lo storico Ettore Ciccotti parlò
di «una specie di antisemitismo italiano» nei confronti degl’italiani
del Sud. La Lega, espressione di un nazionalismo
locale comico, se non fosse tragico, ne è la manifestazione
più sincera.
Ed è accaduto che i meridionali abbiano fatto propri i
pregiudizi di cui erano oggetto. E che, per un processo
d’inversione della colpa, la vittima si sia addossata quella
del carnefice. Succede quando il dolore della colpa che ci
si attribuisce è più tollerabile del male subìto.
Così, la resistenza all’invasore, agli stupri, alla perdita dei
beni, della vita, dell’identità, del proprio paese, è divenuta
“vergogna”. Solo ora, dopo un secolo e mezzo, le famiglie
meridionali che ebbero guerriglieri e patrioti combattenti
cominciano a recuperare l’orgoglio dei propri avi, tutti etichettati
come “briganti” dall’aggressore (naturalmente, il fenomeno
porta all’immeritato riscatto morale pure di chi era
brigante e basta. Di malfattori ce ne furono altri: mafiosi arruolati
da Garibaldi e piemontesi; ma vennero detti “buoni
italiani”. Criminale non è quel che fai, ma per chi lo fai).
Un giorno calcolai quanti miei familiari, da parte di padre
e di madre, sono emigrati (i pugliesi furono gli ultimi a
partire): uno ogni due.
Una mia cugina, dopo sei mesi al Nord, tornò per le ferie
estive (come alcuni volatili, il periodico riapparire degli
emigrati annuncia le stagioni: li chiamavano birds of passage,
“uccelli di passaggio”, nell’America del Nord; e golondrinas,
“rondini”, in quella del Sud). Era cambiata: vestiva
in modo più appariscente, esibiva un accento non suo, roteava
stizzosamente le spalle, il mento puntuto e alto. Parlava
malissimo dei meridionali, con astio rovente e ridicolo.
«Ma cosa fanno di così terribile?» le chiese mia madre, incuriosita.
Lei tacque per lo stupore, si guardò intorno, come
a cercare una risposta. Era sorpresa, o ci parve, dalla
stupidità della domanda: c’era bisogno di una ragione per
parlar male dei meridionali? Così, poverina, se ne uscì con
una frase, lei settentrionale da sei mesi, che la bollò per
sempre, in famiglia: «Sporcano i monumenti».
Come i piccioni; ma, per fortuna, non dall’alto.
Cosa le fosse accaduto, lo capii molto più tardi. Uno dei
miei migliori amici fu tra i primi arrivati della Lega Nord:
abbiamo scoperto di avere la stessa passione per la vela, di
aver acquistato (prima che ci conoscessimo) le stesse barche,
di avere una moglie con lo stesso, non comunissimo
nome, e di averla sposata lo stesso giorno.
Il mio amico si chiama (nooo!) Remo, i suoi nonni sono
di Benevento e di Matera; lui è vissuto a lungo in Argentina,
poi è rientrato in Italia. Sua moglie è veneta, emigrata
dal Polesine in Francia (l’isola di famiglia, alla foce del Po,
finì sommersa, con fattorie e frutteti: da possidenti a naufraghi);
poi è tornata in patria, fra Piemonte e Lombardia.
Leghisti accesi entrambi, fino a quando il movimento
non assunse connotazioni separatiste. «La Lega è piena di
meridionali e di figli di meridionali» mi spiegava Remo.
«Sono i più convinti.» Anche quella mia cugina è leghista.
Perché? Chi emigra, abbandona una comunità e una terra
che figurano deboli e perdenti e mira a radicarsi in un altrove
che appare forte e vincente: l’emigrato non appartiene
più alla sua gente, e non ancora all’altra (così crede). In
cerca di identità, non può che scegliere, lui sradicato e sospeso,
la più forte. E questa sua nuova appartenenza è tanto
più certa, quanto maggiore è la distanza che frappone fra
ciò che era e ciò che vuole essere (in La lingua degli emigrati,
si legge che essi «rivivono nel paese di arrivo la loro situazione
di “dominati” in termini ancor più drammatici»;
e vogliono uscirne. Si educano ad altro da quel che sono.
Quando il carnefice ti toglie tutto, l’unico punto di riferimento
che ti rimane è il carnefice. Lo imiti). Il settentrionale
non ha bisogno di essere leghista; il meridionale al Nord
non può farne a meno, se di scarsa radice. Ed è il più attivo
nel sostenere un’esclusione che non escluda più lui, ma
chi è come lui era. I prossimi leghisti saranno i nipoti degli
extracomunitari. «Ma dubito» avverte Piero Bocchiaro,
studioso di comportamenti psico-sociali alla Vrije Universiteit
di Amsterdam, «che quel che viene mostrato corrisponda
a quel che si è.» Come dire: quello dell’emigrato che
sposa nuovi costumi è un fare che non corrisponde all’essere;
un vivere doppio; non sempre consapevole.
Serve rivangare vecchie storie? Non sono così vecchie da
aver smesso di far male e produrre conseguenze: la storia di
oggi è ancora quella di ieri. La nostra fu interrotta e si può
riannodarla solo nel punto in cui venne spezzata. Non si
può scegliere la ripartenza che più conviene.
Quel che gli italiani venuti dal Nord ci fecero fu così spaventoso,
che ancora oggi lo si tace nei libri di storia e nelle
verità ufficiali; si tengono al buio molti documenti che lo
raccontano. Una parte dell’Italia, in pieno sviluppo, fu condannata
a regredire e depredata dall’altra, che con il bottino
finanziò la propria crescita e prese un vantaggio, poi difeso
con ogni mezzo, incluse le leggi.
La questione meridionale, il ritardo del Sud rispetto al
Nord, non resiste “malgrado” la nascita dell’Italia unita,
ma sorse da quella e dura tuttora, perché è il motore dell’economia
del Nord. Né una sostanziale e improbabile restituzione
del maltolto riporterebbe le cose com’erano:
perdita di fiducia e civiltà provocata nel Sud dalla potatura
dei migliori, con le stragi e l’emigrazione, non è recuperabile
in tempi brevi. Certi processi storici e sociali non
possono essere invertiti a comando; quello economico forse,
sì. Volendo.
Ma non si vuole. E i difetti dei meridionali, ne vogliamo
parlare? No. Almeno qui, no, visto che del Sud si elencano
sempre e solo quelli. Il collega Lino Patruno (Alla riscossa
terroni) ne enumera trentadue; ha ragione e credo si possa
arrivare a sessantaquattro. Lo scopo di Patruno è onesto:
indurre i meridionali alla responsabilità. Ma comincio a temere
che su questo si sia tutti d’accordo; mentre i settentrionali
si ritengano esentati dal fare altrettanto. Così ho
stabilito una personale moratoria: centocinquant’anni bastano;
per i prossimi diciannove mesi, anzi ventuno, voglio
sentire parlare solo dei difetti dei settentrionali. Perché
ogni pecca del Mezzogiorno deve giustificarne la discriminazione,
la minorità, e ogni pretesa del Nord, persino sfacciatamente
razzista, è intesa come diritto? Perché ogni volta
che si parla dell’Italia duale si ignora il meglio del Sud e
il peggio del Nord? E dire il meglio del Sud risulta non credibile,
dire il peggio del Nord è un affronto? «La memoria
è di parte, come parziale è lo sguardo su cui si fonda» rammenta
Walter Barberis (Il bisogno di patria). «Ma la truffa
Parmalat vale, da sola, più che tutte quelle di Napoli, di tutti
i tempi, messe insieme» dice il sindaco che rinnovò Bari,
Michele Emiliano. E passano come incidenti di percorso le
truffe-latte difese dalla Lega, quelle colossali della sanità
lombarda, dai Poggi Longostrevi alle cliniche della morte,
gli sfrenati intrecci affaristici di Comunione e Liberazione...
«La corruttela politica nostra non è male meridionale più
che non sia settentrionale, e non è in essa che si deve cercare
il vero carattere distintivo delle opposte parti d’Italia»
(Ettore Ciccotti, Mezzogiorno e Settentrione d’Italia, 1898).
La Germania Ovest, già nei primi anni di riunificazione
con la più povera Germania Est, spese, nei territori orien-
tali, «una cifra cinque volte superiore a quella che è costata
in questi cinquant’anni la vituperata Cassa per il Mezzogiorno
» (Se il Nord, Agazio Loiero); e ogni anno vi investe
quanto gli Stati Uniti, con il Piano Marshall, inviarono dopo
la guerra, per la ricostruzione dell’intera Europa. Era
l’unico modo per far confluire la ricchezza dell’Ovest dall’altra
parte, sino a pareggiare il livello, in vent’anni. Lì si
volle; e il di più dell’Ovest non era stato rubato all’Est.
Quando una differenza dura così a lungo, si rischia di
non attribuirne più le ragioni alle cause che l’hanno generata
e la mantengono, ma all’insufficienza di chi la patisce.
Così, l’ignorante per ignoranza, il colto per cattiva coscienza,
il razzista per ignoranza e cattiva coscienza, trovano più
comodo spiegare il sottosviluppo economico dei neri con
l’inferiorità della “razza”. Lo si diceva dei lombardi, quando
la loro regione era tenuta dagli austroungarici solo come
area di consumo di beni prodotti altrove. Il Nord era nella
condizione di colonia cui fu condannato il Sud dopo
l’annessione e il saccheggio: è quel «che l’economia capitalistica
fa a’ vinti nella lotta della concorrenza» (ancora Ciccotti).
Anche allora si indagò sugli effetti, per non riconoscerne
le cause. E si cercò di capire perché il lombardo
fosse così incapace, inefficiente, «in una parola, nullo», secondo
la sociologa Cristina Belgioioso, autrice dell’indagine
sulla pochezza dei «padani» (fra i quali, Cesare Lombroso
condusse la ricerca sul «cretinismo perfetto»): i Bossi, i Calderoli
e i Gentilini non nascono dal niente. I “Lombardi”,
come venivano chiamati tutti gli italiani del Nord, erano
giudicati dai francesi “vigliacchi e incapaci”.
La Lombardia «era troppo piccola per alimentare un
sufficiente mercato interno di scambio, e troppo debole
per praticare una politica di espansione industriale fuori
dei suoi confini, qualunque fosse l’aiuto dello stato» scrive
Luigi De Rosa, in La rivoluzione industriale in Italia. «Non
molto migliori risultavano le condizioni industriali del Veneto,
e così quelle della Liguria.»
Il Sud fu unito a forza, svuotato dei suoi beni e soggiogato,
per consentire lo sviluppo del Nord. Cominciarono
allora a sorgere fermenti federalisti lombardi: «Quelli che
parlano di uno “stato di Milano”, per contrapporlo al resto
d’Italia» avvertiva Ciccotti, fanno l’errore di credere «che
Milano sarebbe divenuta qual è senza l’unità d’Italia»; e
«hanno bisogno di dissimularsi le vere cagioni del male, per
vivere de’ frutti del mal di tutti, facendo della diversa lingua
o del diverso dialetto e delle diverse latitudini tante ragioni
di dissidi». Vivere de’ frutti del mal di tutti: fare stare
tutti peggio, per star meglio soltanto loro, con la scusa del
federalismo.
Si chiama rubare. Ed era un secolo fa.
Rammento la conversazione con un collega che stimo,
milanese pratico e di successo. Il tema, visto da Nord (lui),
si riduceva a: «Invece di lamentarsi sempre, i meridionali
potrebbero darsi una mossa»; e visto da Sud (me): «Invece
di continuare a spiegarsi il ritardo del Sud con l’insufficienza
dei meridionali, il Nord potrebbe interrogarsi un po’ di
più sulle cause e non crearne di nuove».
Mark Twain diceva che «siamo tutti esseri umani. Non è
possibile essere qualcosa di peggio». Da noi, qualche tentativo
di dargli torto c’è stato. Salimbene da Parma, ricorda
Barberis (Il bisogno di patria), stimava la viltà dei meridionali
congenita, perché «homines caccarelli et merdacoli».
E per uno dei fondatori del Partito socialista, il bolognese
Camillo Prampolini, gli italiani si dividono in «nordici e sudici
». Uno “scienziato”, poi, confermerà la correttezza della
definizione, per «questi degenerati che abborrono l’acqua
in terra e in mare, che non possono giustificare la loro
immensa sporcizia colla immensa miseria in cui il destino li
ha fatti nascere». E si capisce che, fosse stato lui il destino,
non li avrebbe fatti nascere.
Ma il destino non si cambia e persino lo si merita (o no?).
Sorge il sospetto che, dopo aver fatto l’Italia con il furto
e il sangue, bisognava giustificare il modo. «In quegli anni»
leggi in La razza maledetta. Alle origini del pregiudizio antimeridionale,
di Vito Teti «il dibattito sulla razza e sull’inferiorità
del Mezzogiorno venne condotto in una infinità di
saggi, libri, articoli, interventi, a riprova di come esso non
rispondesse a una moda, ma a esigenze conoscitive, cariche
di un’urgenza politica, sociale, culturale.» La “scienza”
lombrosiana (nata da un soggiorno del suo fondatore di soli
tre mesi in Calabria: un genio da far impallidire Darwin)
avrebbe portato alle attese conclusioni.
Così (in ritardo, ché mio padre non mi aveva detto niente:
o non se n’era accorto o volle risparmiarmi una vergogna
di famiglia), appresi di appartenere a una “razza maledetta”;
e seppi che era dimostrata, con «i fatti», l’inferiorità
«razziale, fisica e psicologica, sociale e morale degl’italiani
del Mezzogiorno, rispetto agli italiani del Settentrione».
Facevo veramente schifo e mi era toccato scoprirlo da solo:
era meglio quando, con i soldi di tutti, aprivano scuole solo
al Nord (l’ha fatto qualcun altro, prima dell’apparente
ministro dell’Istruzione Mariastella Gelmini), perché, se i
terroni imparano a leggere, possono farsi del male. Che ne
sapevo io, di essere, in quanto meridionale, parte di una
sottospecie di «degenerati, barbari, degradati, ritardati»?
E, in trasferta all’estero, per emigrazione (e che altro, se del
Sud?), solo «delinquenti»? Persino in presenza di genio,
trattasi di «genialità malata o infeconda» (Pasquale Rossi).
E un’intera regione, la Calabria, riassunto di tutto il Sud,
poteva essere indicata come «luogo di epilettici-degenerati,
di popolazioni superstiziose, tendenzialmente, per caratteri
razziali e temperamento etnico, criminali». Come vi sentireste,
voi, voi euganei, valdostani o brianzoli, o anche solo
marchigiani, persino soltanto molisani, se scopriste una
cosa del genere non prima, ma dopo aver sposato una calabrese
(ignari di indizi rivelatori, quali «la fronte declive e il
diametro bimandibolare accentuato»)? Mettermi in casa
una della regione «più odiata d’Italia»! E la poveretta di
mia moglie mi avrebbe evitato, se avesse conosciuto lo
“studio” che “certificava” (“scientificamente”, e si capisce)
l’ozio, l’indolenza, l’apatia, l’accidia dei pugliesi? Per una
parte non breve della mia vita, mi sono aggirato per questo
paese, inconsapevole della classificazione craniologica, secondo
la quale le teste dolicocefale del Sud erano chiaro
indice di inferiorità, rispetto alle capocce brachicefale che
testimoniavano la superiorità dei settentrionali. Di Borghezio,
avete presente? O Renzo Bossi (tutto papà suo), l’intellettuale
che riesce a diplomarsi in appena quattro tentativi;
dopo di che, per frenare la fuga dei cervelli dall’Italia il
Nord l’ha incaricato di “vigilare” sul sistema fieristico lombardo.
I meridionali, per Massimo D’Azeglio, erano «carne che
puzzava» (la storia tace sul suo alito). Ma si è sempre i meridionali
di qualcuno. Ed è un guaio, perché vuol dire che
chi stila graduatorie finisce in quelle di altri.
E perché si fanno le classifiche, a cosa servono?
A degli studenti-cavia, volontari, si chiese di sopprimere,
pigiando un bottone, esseri viventi, secondo una scala di
prossimità biologica alla specie homo sapiens sapiens. Era
tutto finto: non moriva nessuno; ma loro non lo sapevano
ed erano convinti di uccidere, in un crescendo omicida, microbi,
insetti, invertebrati, pesci, uccelli, serpenti, topi, gatti,
cani, scimmie... Alcuni si fermarono agli uccelli; altri trovarono
intollerabile accoppare gatti o cani, solo per un
esperimento; ci fu chi rifiutò di proseguire solo quando gli
fu chiesto di eliminare le scimmie; e chi eseguì anche quel
comando. Un esperimento analogo fu compiuto con esseri
umani nel ruolo di “vittime”. A studenti-cavie fu chiesto di
infliggere scariche elettriche sempre più pericolose. Erano
fasulle, ma non lo sapeva chi azionò la manopola sino all’ultimo
giro. La scienza, il progresso, la civiltà richiedono
qualche sacrificio, e si trova sempre qualcuno disposto a
farlo fare ad altri.
Anche fra gli esseri umani sono state fatte graduatorie:
schiavi, servitori e padroni; poveri e ricchi; negri, sangue-
misti e bianchi; meridionali, terroni nordicizzati e settentrionali...
Di nuovo: a cosa servono le classificazioni? Gli studenticavia
ci hanno dato la risposta: a stabilire chi deve soffrire
o morire prima, “per il bene di tutti” (cioè di quelli che
hanno deciso a chi tocca prima). Le classifiche sono la giustificazione
necessaria, perché questo avvenga senza rimorso,
“per una buona ragione”. Napoleone Colajanni ricordava
quegli «antroposociologici che, per vedere progredire e
migliorare l’umanità, vorrebbero distruggerne almeno una
buona metà».
Hitler ci provò. Ma quando avviò lo sterminio dei minorati
mentali, la Germania insorse e persino la ferocia nazista
dovette desistere per le proteste popolari. Le vittime designate
erano minorati, ma ariani. Quando si fece la stessa
cosa con gli ebrei e gli zingari, la Germania tacque.
Nella civile Treviso, un sindaco può proporre vagoni
blindati per espellere gli extracomunitari, il loro uso come
prede per i cacciatori locali, la rimozione delle panchine
dal centro, per impedire che siano contaminate da terga extracomunitarie.
E viene rieletto. Ma quando chiude lo stesso
salotto cittadino ai cani domestici (e alle loro deiezioni),
la popolazione scende in piazza e protesta. Nella scala delle
dignità difendibili (o almeno delle sensibilità civili), Treviso
pone i cani (e persino le loro feci, a doverla dire tutta)
più in alto degli extracomunitari. Non è un’opinione; è un
fatto: per Fido si sentirono offesi; per Abdul, non abbastanza.
Le classificazioni sono gradini, indicano la direzione della
violenza che le genera: dall’alto in basso. La quantità di
violenza è proporzionale alla tenuta delle norme del vivere
civile. Se queste si indeboliscono, abbiamo visto con quanta
facilità si passi dalle sparate comico-razziste dell’intellighenzia
balcanica (poco o per niente dissimili da quelle dei
Bossi, dei Salvini, dei Calderoli, dei Gentilini) alla pulizia
etnica. Il mio saggio amico Fulvio Molinari, giornalista e
scrittore, ne ha paura: «Noi triestini l’abbiamo visto succedere
alle porte di casa: chi abusa delle parole viene travolto
dai fatti. Non si rendono conto». E pensate se, invece, se
ne rendono pure conto... Trieste queste cose le percepisce
prima e meglio degli altri, per la sensibilità della frontiera.
Paolo Rumiz si è mosso da lì per il suo viaggio fra le inquietudini
del Nord; e, in La secessione leggera, riporta le parole
di un suo amico di Sarajevo: «Non è stato il fracasso dei
cannoni a uccidere la Iugoslavia. È stato il silenzio. Il silenzio
sul linguaggio della violenza, prima che sulla violenza».
Le scritte «Forza Etna», «Forza terremoto» comparse
nel Nord (e il cui ricordo commuove e inorgoglisce i leghisti
della prima ora, con la memoria degli eroici inizi) celano,
sotto un’apparente esagerazione dialettica, un desiderio
vero, profondo. Un desiderio criminale: a gente a cui il vulcano
distruggeva case, aziende o a cui il terremoto uccideva
i familiari, qualcuno augurava di peggio; e per questo otteneva
voti, consenso sociale. Vergogna per loro; e per chi
consentiva e consente.
Quella violenza è solo verbale, ma va nel senso della
classificazione, perché quando il Po uscì dagli argini, distrusse
case, fece vittime o quando l’ictus paralizzò Bossi,
nessuno al Sud scrisse sui viadotti dell’autostrada: «Forza
Po» e «Forza ictus». La differenza fra le scritte leghiste e
l’assenza di risposta può essere in qualche millennio di storia
in più (magari!), o nell’accettazione del ruolo dei vinti
(più probabile).
L’aggressione leghista ha indotto molti a sentirsi meridionali,
a riscoprire la propria storia; che i settentrionali
preferiscono ignorare, un po’ perché credono di aver già
capito quel che c’è da capire; un po’ perché non gl’interessa
sapere del Sud, che associano a un’idea di cultura inutilmente
contorta, elaborata, improduttiva, perdente e pretenziosa
(insomma, un misto di invidiuzza e disprezzo per
quegl’«intellettuali della Magna Grecia» che sanno un sacco
di cose che non servono a niente); un po’ perché, nella ri-
cerca di radici diverse e distanti, piuttosto che coltivare la
ricchezza delle proprie, si trastullano con la patacca della
“cultura celtica”. Comprensibile la “voglia di passato”, ma
perché forzarne un aspetto per adattarlo a un desiderio del
presente? Si rischia la caricatura, come il kilt, il gonnellino
degli scozzesi, che è un’invenzione folcloristica recente; o il
«sole delle Alpi», quel fiore a sei petali, scelto dai leghisti
quale loro simbolo, ma diffuso da sempre un po’ ovunque,
e abbondantemente nel Mediterraneo: era già sugli scudi
dei guerrieri di Puglia (però zona-Nord, eh?), più di tremila
anni fa. Sciur Asterix de la Briansa, quello è il sole del
Tavoliere! Ch’el vaga schisc anca (Ci vada piano pure) con
l’avo barbarico: al Nord lasciò il nome a una regione, mentre
al Sud i suoi stati e le sue leggi nei tribunali sopravvissero
ancora per quasi tre secoli, e con tale forza ed estensione
(parte della Campania, della Basilicata, della Puglia e
della Calabria) che, nelle mappe dell’epoca, la “capitale di
Longobardia” era Bari. Terun! Ma questo libro parla della
costruzione della minorità del Mezzogiorno, così, tanto vale
dirlo subito: il pur più duraturo stato meridionale di quei
barbari che vennero a civilizzarsi in casa nostra passò alla
storia con il nome di “Langobardia Minor” (e te pareva!).
«Quando non si vuol fare qualcosa per capirla,» ha scritto
Marco Paolini «si trasforma la storia in geografia.» E accettiamo
che, contro il valore dei fatti, la geografia divenga
comunque vincente, se segna Nord e comunque perdente,
se segna Sud? E che la latitudine misuri il valore degli uomini,
delle loro azioni, dei loro diritti? Ma non è esattamente
questa l’essenza unica, piena, del razzismo? Non è nella
facilità di tale promessa il suo successo con gli stupidi e gli
egoisti?
«Le identità plurali sono percepite dai nazionalismi come
altrettante minacce» scrive Predrag Matvejevic´ in Mondo
ex e tempo del dopo. E spiega che è proprio nelle «nazioni
venute tardi», come l’Italia, che «queste malattie di
identità» colpiscono più facilmente.
Il Settentrione ne patisce, perché scellerate scelte politiche
ed economiche hanno (de)portato al Nord alcuni milioni
di meridionali, con i loro dialetti, le loro diete, le loro
abitudini. Per quanto essi abbiano cercato di assimilare
nuovi accenti e costumi, i propri hanno influito su quelli altrui;
sapori e amori si sono fusi, generando un meticciato
avvertito come minaccia per l’identità del Nord. La Lega,
l’invenzione di riti celtico-padano-veneti sono furbate politiche
per trasformare in voti il bisogno di riscoprire radici
e armarle di razzismo («Decidemmo di sfruttare l’antimeridionalismo
diffuso in Lombardia, come in altre regioni del
Nord» ammette lo spudorato Umberto Bossi nel Mein
Kampf della Lega, il suo Vento dal Nord).
E ne patisce il Sud, che ha meglio conservato il colore
delle radici (indebolite dall’esodo, ma non stemperate da
tradizioni diverse), pur se nei comportamenti è stato indotto
a rinnegarle, a ritenerle superate, scadenti, sconfitte. Come
per gli ebrei convertiti a forza, gli è toccato sentire in un
modo e agire in un altro. Finché, col tempo e le generazioni,
quel sentire si è fatto flebile; salvo riaccendersi, per l’offesa,
e proporsi “contro”.
La tardiva scoperta di essere meridionale mi ha rivelato
un assurdo: i meridionali traggono il nome da quel che gli
manca: il Sud. E pure quando la geografia gliene offriva
uno (le infelici avventure contadine dei siciliani in Libia, in
Tunisia), la storia glielo ha negato. Il mondo dei meridionali
ha una direzione in meno: più giù di dove sono non si
può andare, restando “a casa”. Il Sud porta con sé un’idea
di gioia e di nostalgia; se la prima è data dal clima, dalla natura,
l’altra (come accade, a volte, dopo un’amputazione)
viene dal dolore dell’arto fantasma: fa male quello che non
c’è. Il Sud. Ed è una negazione pesante.
L’estremo lembo di alcune regioni, che il sentimento proprio
e altrui percepisce “al confine del mondo”, è chiamato,
in Galizia come in Cornovaglia o in Bretagna: Finisterrae. In
Italia un posto così è in Puglia, a Santa Maria di Leuca: lì il
mare si alza come un muro, a chiudere il discorso. La Puglia
è un dito di terra lungo quasi quattrocento chilometri,
ma largo poco più di trenta, verso Leuca. Significa che non
solo ci manca il Sud (Finisterrae), ma altre due direzioni,
l’Est e l’Ovest, sono appena abbozzate. Si intuisce altro, da
qui, a cui non pensi se hai intorno un orizzonte completo e
percorribile. Può trattarsi della direzione negata della vita.
Un settentrionale può volgere gli occhi e cercarsi il futuro
in ogni parte. Un meridionale, no: è costretto a guardare
solo verso Nord: dalla storia, dall’economia figlia di quella
storia, e persino dalla geografia. In realtà, nemmeno il settentrionale
ha davvero scelta; se rinuncia al Sud, come
quattro scriteriati vorrebbero, cade nella nostra condizione
(ma in modo artificioso, falso, quindi sterile): quella degli
amputati. Mentre a noi tocca un arto fantasma che ti
rende fertile (perché non è la tua volontà a privartene), a
prezzo di un dolore necessario: chi non raggiunge e comprende
Finisterrae (la parte che manca) non sa il suo limite,
non sa quel che vale. E si vede.
PIEMME
Realizzazione editoriale: Conedit Libri Srl, Cormano (MI)
© 2010 by Pino Aprile
This book was negotiated through Ute Körner Literary Agent, S.L., Barcelona –
www.uklitag.com
I Edizione 2010
© 2010 - EDIZIONI PIEMME Spa
20145 Milano - Via Tiziano, 32
info@edizpiemme.it - www.edizpiemme.it
PINO APRILE
TERRONI
Diventare meridionali
Io non sapevo che i piemontesi fecero al Sud quello che i
nazisti fecero a Marzabotto. Ma tante volte, per anni.
E cancellarono per sempre molti paesi, in operazioni
“anti-terrorismo”, come i marines in Iraq.
Non sapevo che, nelle rappresaglie, si concessero libertà
di stupro sulle donne meridionali, come nei Balcani, durante
il conflitto etnico; o come i marocchini delle truppe
francesi, in Ciociaria, nell’invasione, da Sud, per redimere
l’Italia dal fascismo (ogni volta che viene liberato, il Mezzogiorno
ci rimette qualcosa).
Ignoravo che, in nome dell’Unità nazionale, i fratelli
d’Italia ebbero pure diritto di saccheggio delle città meridionali,
come i Lanzichenecchi a Roma.
E che praticarono la tortura, come i marines ad Abu
Ghraib, i francesi in Algeria, Pinochet in Cile.
Non sapevo che in Parlamento, a Torino, un deputato ex
garibaldino paragonò la ferocia e le stragi piemontesi al
Sud a quelle di «Tamerlano, Gengis Khan e Attila». Un altro
preferì tacere «rivelazioni di cui l’Europa potrebbe
inorridire». E Garibaldi parlò di «cose da cloaca».
Né che si incarcerarono i meridionali senza accusa, senza
processo e senza condanna, come è accaduto con gl’islamici
a Guantánamo. Lì qualche centinaio, terroristi per
definizione, perché musulmani; da noi centinaia di migliaia,
briganti per definizione, perché meridionali. E, se bambini,
briganti precoci; se donne, brigantesse o mogli, figlie, di briganti;
o consanguinei di briganti (sino al terzo grado di parentela);
o persino solo paesani o sospetti tali. Tutto a norma
di legge, si capisce, come in Sudafrica, con l’apartheid.
Io credevo che i briganti fossero proprio briganti, non
anche ex soldati borbonici e patrioti alla guerriglia per difendere
il proprio paese invaso.
Non sapevo che il paesaggio del Sud divenne come quello
del Kosovo, con fucilazioni in massa, fosse comuni, paesi
che bruciavano sulle colline e colonne di decine di migliaia
di profughi in marcia.
Non volevo credere che i primi campi di concentramento
e sterminio in Europa li istituirono gli italiani del Nord,
per tormentare e farvi morire gli italiani del Sud, a migliaia,
forse decine di migliaia (non si sa, perché li squagliavano
nella calce), come nell’Unione Sovietica di Stalin.
Ignoravo che il ministero degli Esteri dell’Italia unita
cercò per anni «una landa desolata», fra Patagonia, Borneo
e altri sperduti lidi, per deportarvi i meridionali e annientarli
lontano da occhi indiscreti.
Né sapevo che i fratelli d’Italia arrivati dal Nord svuotarono
le ricche banche meridionali, regge, musei, case private
(rubando persino le posate), per pagare i debiti del Piemonte
e costituire immensi patrimoni privati.
E mai avrei immaginato che i Mille fossero quasi tutti
avanzi di galera.
Non sapevo che, a Italia così unificata, imposero una tassa
aggiuntiva ai meridionali, per pagare le spese della guerra
di conquista del Sud, fatta senza nemmeno dichiararla.
Ignoravo che l’occupazione del Regno delle Due Sicilie
fosse stata decisa, progettata, protetta da Inghilterra e
Francia, e parzialmente finanziata dalla massoneria (detto
da Garibaldi, sino al gran maestro Armando Corona, nel
1988).
Né sapevo che il Regno delle Due Sicilie fosse, fino al
momento dell’aggressione, uno dei paesi più industrializzati
del mondo (terzo, dopo Inghilterra e Francia, prima di
essere invaso).
E non c’era la “burocrazia borbonica”, intesa quale caotica
e inefficiente: lo specialista inviato da Cavour nelle Due
Sicilie, per rimettervi ordine, riferì di un «mirabile organismo
finanziario» e propose di copiarla, in una relazione che
è «una lode sincera e continua». Mentre «il modello che
presiede alla nostra amministrazione», dal 1861, «è quello
franco-napoleonico, la cui versione sabauda è stata modulata
dall’unità in avanti in adesione a una miriade di pressioni
localistiche e corporative» (Marco Meriggi, Breve storia
dell’Italia settentrionale).
Ignoravo che lo stato unitario tassò ferocemente i milioni
di disperati meridionali che emigravano in America, per
assistere economicamente gli armatori delle navi che li trasportavano
e i settentrionali che andavano a “far la stagione”,
per qualche mese in Svizzera.
Non potevo immaginare che l’Italia unita facesse pagare
più tasse a chi stentava e moriva di malaria nelle caverne
dei Sassi di Matera, rispetto ai proprietari delle ville sul lago
di Como.
Avevo già esperienza delle ferrovie peggiori al Sud che al
Nord, ma non che, alle soglie del 2000, col resto d’Italia
percorso da treni ad alta velocità, il Mezzogiorno avesse
quasi mille chilometri di ferrovia in meno che prima della
Seconda guerra mondiale (7.958 contro 8.871), quasi sempre
ancora a binario unico e con gran parte della rete non
elettrificata.
Come potevo immaginare che stessimo così male, nell’inferno
dei Borbone, che per obbligarci a entrare nel paradiso
portatoci dai piemontesi ci vollero orribili rappresaglie,
stragi, una dozzina di anni di combattimenti, leggi
speciali, stati d’assedio, lager? E che, quando riuscirono a
farci smettere di preferire la morte al loro paradiso, sce-
gliemmo piuttosto di emigrare a milioni (e non era mai successo)?
Ignoravo che avrei dovuto studiare il francese, per apprendere
di essere italiano: «Le Royaume d’Italie est
aujourd’hui un fait» annunciò Cavour al Senato. «Le Roi notre
auguste Souverain prend pour lui-même et pour ses successeurs
le titre de Roi d’Italie.»
Credevo al Giosue Carducci delle Letture del Risorgimento
italiano: «Né mai unità di nazione fu fatta per aspirazione
di più grandi e pure intelligenze, né con sacrifici di più
nobili e sante anime, né con maggior libero consentimento
di tutte le parti sane del popolo». Affermazione riportata in
apertura del libro (Il Risorgimento italiano) distribuito gratuitamente
dai Centri di Lettura e Informazione a cura del
ministero della Pubblica Istruzione Direzione Generale per
l’Educazione Popolare, dal 1964. Il curatore, Alberto M.
Ghisalberti, avverte che, «a un secolo di distanza (...), la revisione
critica operata dagli storici possa suggerire interpretazioni
diversamente meditate (...) della più complessa
realtà del “libero consentimento” al quale si riferisce il
poeta». Chi sa, capisce; chi non sa, continua a non capire.
Scoprirò poi che Carducci, privatamente, scriveva: «A Lei
pare una bella cosa questa Italia?»; tanto che, per lui, evitare
di parlarne «può anche essere opera di carità». (Storia
d’Italia, Einaudi).
Io avevo sempre creduto ai libri di storia, alla leggenda
di Garibaldi.
Non sapevo nemmeno di essere meridionale, nel senso
che non avevo mai attribuito alcun valore, positivo o negativo,
al fatto di essere nato più a Sud o più a Nord di un altro.
Mi ritenevo solo fortunato a essere nato italiano. E fra
gl’italiani più fortunati, perché vivevo sul mare.
A mano a mano che scoprivo queste cose, ne parlavo. Io
stupito; gli ascoltatori increduli. Poi, io furioso; gli ascoltatori
seccati: esagerazioni, invenzioni e, se vere, cose vecchie.
E mi accorsi che diventavo meridionale, perché, stupidamente,
maturavo orgoglio per la geografia di cui, altrettanto
stupidamente, Bossi e complici volevano che mi vergognassi.
Loro che usano “italiano” come un insulto e
abitano la parte della penisola che fu denominata “Italia”,
quando Roma riorganizzò l’impero (quella meridionale
venne chiamata “Apulia”, dal nome della mia regione. Ma
la prima “Italia” della storia fu un pezzo di Calabria sul
Tirreno).
Si è scritto tanto sul Sud, ma non sembra sia servito a
molto, perché «ogni battaglia contro pregiudizi universalmente
condivisi è una battaglia persa» dice Nicholas
Humphrey (Una storia della mente). «Perché non riprendi
una delle tante pubblicazioni meridionaliste di venti,
trent’anni fa, e la ristampi tale e quale? Chi si accorgerebbe
che del tempo è passato, inutilmente?» suggeriva ottant’anni
fa a Piero Gobetti, Tommaso Fiore che poi, per
fortuna, scrisse Un popolo di formiche. E oggi, un economista
indomito, Gianfranco Viesti (Abolire il Mezzogiorno),
allarga le braccia: «Parlare di Mezzogiorno significa parlare
del già detto, e del già fallito».
Perché tale stato di cose è utile alla parte più forte del
paese, anche se si presenta con due nomi diversi: “Questione
meridionale”, ovvero dell’aspirazione del Sud a uscire
dalla subalternità impostagli; e “Questione settentrionale”,
di recente conio, ovvero della volontà del Nord di mantenere
la subalternità del Sud e il redditizio vantaggio di potere
conquistato con le armi e una legislazione squilibrata.
Dopo centocinquant’anni, questo sistema rischia di spezzare
il paese. Si sa; e si finge di non saperlo, perché troppi sono
gl’interessi che se ne nutrono.
Così, accade che la verità venga scritta, ma non sia letta;
e se letta, non creduta; e se creduta, non presa in considerazione;
e se presa in considerazione, non tanto da cambiare
i comportamenti, da indurre ad agire “di conseguenza”.
I meridionali si lamentano sempre e i carcerati si dicono
tutti innocenti. Il paragone non è casuale; nel bel libro Sull’identità
meridionale, Mario Alcaro scrive: «Si può dire
che è la difesa di un imputato, di un cittadino del Sud che
cerca una risposta alle tante critiche e accuse che gli son
piovute addosso». Il pregiudizio (pre, “prima”) è una condanna
senza processo. Sospetto che la sua persistenza eviti,
a chi lo nutre, un’ammissione di colpa. «L’uomo è un animale
mosso in modo determinante dalla colpa» rammenta
Luigi Zoja in Storia dell’arroganza. «Un sentimento di colpa
può essere spostato, non cancellato.» E il Nord aggressore
incolpa l’aggredito delle conseguenze dell’aggressione:
rimosso il rimorso, se mai c’è stato.
Noi meridionali conosciamo bene tutto questo: non ci
indigna nemmeno più; ci stanca: «Senti che la gente ti capisce
male, che devi parlare più forte, gridare» spiegava
Cˇechov. «E le grida sono ripugnanti. Parli a voce sempre
più bassa, forse tra poco tacerai del tutto.» Fra le urla dell’altro,
ormai privo del freno della vergogna che lo rendeva
civile.
Oggi, nuovi fermenti animano una ricerca di verità storica,
non solo meridionale, che viene dal basso, più che dalle
aule universitarie o dalla politica, dalle istituzioni. Non è facile
capire dove questo possa portare; se a un revanscismo
uguale e opposto al razzismo nordista di Lega e collaterali,
o a una comune crescita di consapevolezza e conoscenza:
un nuovo meridionalismo non solo meridionale (e sarebbe
un ritorno alle origini, perché nacque nordico, specie lombardo),
per ridare un’anima decente a un’Italia che l’ha
smarrita, nel fallimento della politica e la sua riduzione a furia
predatoria di egoismi personali e territoriali. Temo, per
il pessimismo della ragione e perché i segni vanno in quella
direzione, che il peggio prevalga, proprio “per” e non
“nonostante” i suoi difetti (è la legge di Greg e Galton, che
ricordo in Elogio dell’imbecille). Ma, per l’ottimismo della
volontà, spero nel contrario (nemmeno il peggio dura per
sempre; e anche i peggiori muoiono).
Il Nord, visto da Sud, è Caino: da lì vennero quelli che,
dicendosi fratelli, compirono al Sud, a scopo di rapina, il
massacro più imponente mai subito da queste regioni (e sì
che di barbari ne sono passati). I musei del Risorgimento,
nota Mario Isnenghi, nella sua Breve storia dell’Italia unita
a uso dei perplessi, sono quasi tutti al Centro o al Nord.
Il Nord è dove ho lavorato anni e ho amici, ed è casa mia;
come il Sud, dove sono nato; o il Centro, dove abito. Gl’italiani
vanno al Nord in cerca di soldi; al Sud in cerca dell’anima.
All’estero smettono di essere meridionali o settentrionali
e diventano solo italiani (indistintamente, nel
pregiudizio altrui, geni e farabutti).
Il Sud, visto da Nord, è L’inferno, titolo del libro di Giorgio
Bocca che nel 2008 ha scritto sul «Venerdì» di «Repubblica
», non so quanto provocatoriamente: «Sì, è vero, sono
un antimeridionale... Passo per razzista, e forse lo sono».
Nessuno vi trovò da ridire: è o no il Sud, nella geografia, anche
morale, il luogo del male? Del male senza possibilità di
redenzione: ché questo è l’inferno, congrua immagine del
«paradiso abitato da diavoli», secondo l’Alexandre Dumas
che accompagnò Garibaldi (e a che prezzo!) alla conquista
e al saccheggio.
Caino, al contrario, è un’espressione più saggia e attenta
alla verità, perché Caino non è perso per sempre, a differenza
di chi precipita all’inferno: gli viene offerta una possibilità
di riscatto, in un’altra terra. Anche se non la coglie.
Né pare vogliano farlo, oggi, tanti che ancora godono del
vantaggio ereditato da chi venne a sterminarci. Quando
scrivo “i settentrionali”, “i piemontesi”, non intendo generalizzare
(come avviene quando si parla di “meridionali”).
Alcuni dei più grandi meridionalisti erano del Nord; e gli
ascari che in Parlamento votano (dal 1861) contro l’equità
per le regioni che li hanno eletti, sono meridionali.
Il Sud è stato privato delle sue istituzioni; fu privato delle
sue industrie, della sua ricchezza, della capacità di reagire;
della sua gente (con una emigrazione indotta o forzata
senza pari in Europa); infine, con un’operazione di lobotomia
culturale, fu privato della consapevolezza di sé, della
memoria.
Noi non sappiamo più chi fummo. Ed è accaduto come
agli ebrei travolti dall’Olocausto (il paragone non è esagerato:
centinaia di migliaia, forse un milione di meridionali
furono sterminati dalle truppe sabaude; da tredici a oltre
venti milioni, secondo i conteggi, dovettero abbandonare la
loro terra, in un secolo): molti scampati ai lager cominciarono
a domandarsi se il male che li aveva investiti non fosse
in qualche modo meritato. Quando il danno è intollerabile,
cercare una colpa, pur assurda, inesistente, che lo
renda comprensibile (non giustificabile), diventa una via
per non perdere la ragione. Lo storico Ettore Ciccotti parlò
di «una specie di antisemitismo italiano» nei confronti degl’italiani
del Sud. La Lega, espressione di un nazionalismo
locale comico, se non fosse tragico, ne è la manifestazione
più sincera.
Ed è accaduto che i meridionali abbiano fatto propri i
pregiudizi di cui erano oggetto. E che, per un processo
d’inversione della colpa, la vittima si sia addossata quella
del carnefice. Succede quando il dolore della colpa che ci
si attribuisce è più tollerabile del male subìto.
Così, la resistenza all’invasore, agli stupri, alla perdita dei
beni, della vita, dell’identità, del proprio paese, è divenuta
“vergogna”. Solo ora, dopo un secolo e mezzo, le famiglie
meridionali che ebbero guerriglieri e patrioti combattenti
cominciano a recuperare l’orgoglio dei propri avi, tutti etichettati
come “briganti” dall’aggressore (naturalmente, il fenomeno
porta all’immeritato riscatto morale pure di chi era
brigante e basta. Di malfattori ce ne furono altri: mafiosi arruolati
da Garibaldi e piemontesi; ma vennero detti “buoni
italiani”. Criminale non è quel che fai, ma per chi lo fai).
Un giorno calcolai quanti miei familiari, da parte di padre
e di madre, sono emigrati (i pugliesi furono gli ultimi a
partire): uno ogni due.
Una mia cugina, dopo sei mesi al Nord, tornò per le ferie
estive (come alcuni volatili, il periodico riapparire degli
emigrati annuncia le stagioni: li chiamavano birds of passage,
“uccelli di passaggio”, nell’America del Nord; e golondrinas,
“rondini”, in quella del Sud). Era cambiata: vestiva
in modo più appariscente, esibiva un accento non suo, roteava
stizzosamente le spalle, il mento puntuto e alto. Parlava
malissimo dei meridionali, con astio rovente e ridicolo.
«Ma cosa fanno di così terribile?» le chiese mia madre, incuriosita.
Lei tacque per lo stupore, si guardò intorno, come
a cercare una risposta. Era sorpresa, o ci parve, dalla
stupidità della domanda: c’era bisogno di una ragione per
parlar male dei meridionali? Così, poverina, se ne uscì con
una frase, lei settentrionale da sei mesi, che la bollò per
sempre, in famiglia: «Sporcano i monumenti».
Come i piccioni; ma, per fortuna, non dall’alto.
Cosa le fosse accaduto, lo capii molto più tardi. Uno dei
miei migliori amici fu tra i primi arrivati della Lega Nord:
abbiamo scoperto di avere la stessa passione per la vela, di
aver acquistato (prima che ci conoscessimo) le stesse barche,
di avere una moglie con lo stesso, non comunissimo
nome, e di averla sposata lo stesso giorno.
Il mio amico si chiama (nooo!) Remo, i suoi nonni sono
di Benevento e di Matera; lui è vissuto a lungo in Argentina,
poi è rientrato in Italia. Sua moglie è veneta, emigrata
dal Polesine in Francia (l’isola di famiglia, alla foce del Po,
finì sommersa, con fattorie e frutteti: da possidenti a naufraghi);
poi è tornata in patria, fra Piemonte e Lombardia.
Leghisti accesi entrambi, fino a quando il movimento
non assunse connotazioni separatiste. «La Lega è piena di
meridionali e di figli di meridionali» mi spiegava Remo.
«Sono i più convinti.» Anche quella mia cugina è leghista.
Perché? Chi emigra, abbandona una comunità e una terra
che figurano deboli e perdenti e mira a radicarsi in un altrove
che appare forte e vincente: l’emigrato non appartiene
più alla sua gente, e non ancora all’altra (così crede). In
cerca di identità, non può che scegliere, lui sradicato e sospeso,
la più forte. E questa sua nuova appartenenza è tanto
più certa, quanto maggiore è la distanza che frappone fra
ciò che era e ciò che vuole essere (in La lingua degli emigrati,
si legge che essi «rivivono nel paese di arrivo la loro situazione
di “dominati” in termini ancor più drammatici»;
e vogliono uscirne. Si educano ad altro da quel che sono.
Quando il carnefice ti toglie tutto, l’unico punto di riferimento
che ti rimane è il carnefice. Lo imiti). Il settentrionale
non ha bisogno di essere leghista; il meridionale al Nord
non può farne a meno, se di scarsa radice. Ed è il più attivo
nel sostenere un’esclusione che non escluda più lui, ma
chi è come lui era. I prossimi leghisti saranno i nipoti degli
extracomunitari. «Ma dubito» avverte Piero Bocchiaro,
studioso di comportamenti psico-sociali alla Vrije Universiteit
di Amsterdam, «che quel che viene mostrato corrisponda
a quel che si è.» Come dire: quello dell’emigrato che
sposa nuovi costumi è un fare che non corrisponde all’essere;
un vivere doppio; non sempre consapevole.
Serve rivangare vecchie storie? Non sono così vecchie da
aver smesso di far male e produrre conseguenze: la storia di
oggi è ancora quella di ieri. La nostra fu interrotta e si può
riannodarla solo nel punto in cui venne spezzata. Non si
può scegliere la ripartenza che più conviene.
Quel che gli italiani venuti dal Nord ci fecero fu così spaventoso,
che ancora oggi lo si tace nei libri di storia e nelle
verità ufficiali; si tengono al buio molti documenti che lo
raccontano. Una parte dell’Italia, in pieno sviluppo, fu condannata
a regredire e depredata dall’altra, che con il bottino
finanziò la propria crescita e prese un vantaggio, poi difeso
con ogni mezzo, incluse le leggi.
La questione meridionale, il ritardo del Sud rispetto al
Nord, non resiste “malgrado” la nascita dell’Italia unita,
ma sorse da quella e dura tuttora, perché è il motore dell’economia
del Nord. Né una sostanziale e improbabile restituzione
del maltolto riporterebbe le cose com’erano:
perdita di fiducia e civiltà provocata nel Sud dalla potatura
dei migliori, con le stragi e l’emigrazione, non è recuperabile
in tempi brevi. Certi processi storici e sociali non
possono essere invertiti a comando; quello economico forse,
sì. Volendo.
Ma non si vuole. E i difetti dei meridionali, ne vogliamo
parlare? No. Almeno qui, no, visto che del Sud si elencano
sempre e solo quelli. Il collega Lino Patruno (Alla riscossa
terroni) ne enumera trentadue; ha ragione e credo si possa
arrivare a sessantaquattro. Lo scopo di Patruno è onesto:
indurre i meridionali alla responsabilità. Ma comincio a temere
che su questo si sia tutti d’accordo; mentre i settentrionali
si ritengano esentati dal fare altrettanto. Così ho
stabilito una personale moratoria: centocinquant’anni bastano;
per i prossimi diciannove mesi, anzi ventuno, voglio
sentire parlare solo dei difetti dei settentrionali. Perché
ogni pecca del Mezzogiorno deve giustificarne la discriminazione,
la minorità, e ogni pretesa del Nord, persino sfacciatamente
razzista, è intesa come diritto? Perché ogni volta
che si parla dell’Italia duale si ignora il meglio del Sud e
il peggio del Nord? E dire il meglio del Sud risulta non credibile,
dire il peggio del Nord è un affronto? «La memoria
è di parte, come parziale è lo sguardo su cui si fonda» rammenta
Walter Barberis (Il bisogno di patria). «Ma la truffa
Parmalat vale, da sola, più che tutte quelle di Napoli, di tutti
i tempi, messe insieme» dice il sindaco che rinnovò Bari,
Michele Emiliano. E passano come incidenti di percorso le
truffe-latte difese dalla Lega, quelle colossali della sanità
lombarda, dai Poggi Longostrevi alle cliniche della morte,
gli sfrenati intrecci affaristici di Comunione e Liberazione...
«La corruttela politica nostra non è male meridionale più
che non sia settentrionale, e non è in essa che si deve cercare
il vero carattere distintivo delle opposte parti d’Italia»
(Ettore Ciccotti, Mezzogiorno e Settentrione d’Italia, 1898).
La Germania Ovest, già nei primi anni di riunificazione
con la più povera Germania Est, spese, nei territori orien-
tali, «una cifra cinque volte superiore a quella che è costata
in questi cinquant’anni la vituperata Cassa per il Mezzogiorno
» (Se il Nord, Agazio Loiero); e ogni anno vi investe
quanto gli Stati Uniti, con il Piano Marshall, inviarono dopo
la guerra, per la ricostruzione dell’intera Europa. Era
l’unico modo per far confluire la ricchezza dell’Ovest dall’altra
parte, sino a pareggiare il livello, in vent’anni. Lì si
volle; e il di più dell’Ovest non era stato rubato all’Est.
Quando una differenza dura così a lungo, si rischia di
non attribuirne più le ragioni alle cause che l’hanno generata
e la mantengono, ma all’insufficienza di chi la patisce.
Così, l’ignorante per ignoranza, il colto per cattiva coscienza,
il razzista per ignoranza e cattiva coscienza, trovano più
comodo spiegare il sottosviluppo economico dei neri con
l’inferiorità della “razza”. Lo si diceva dei lombardi, quando
la loro regione era tenuta dagli austroungarici solo come
area di consumo di beni prodotti altrove. Il Nord era nella
condizione di colonia cui fu condannato il Sud dopo
l’annessione e il saccheggio: è quel «che l’economia capitalistica
fa a’ vinti nella lotta della concorrenza» (ancora Ciccotti).
Anche allora si indagò sugli effetti, per non riconoscerne
le cause. E si cercò di capire perché il lombardo
fosse così incapace, inefficiente, «in una parola, nullo», secondo
la sociologa Cristina Belgioioso, autrice dell’indagine
sulla pochezza dei «padani» (fra i quali, Cesare Lombroso
condusse la ricerca sul «cretinismo perfetto»): i Bossi, i Calderoli
e i Gentilini non nascono dal niente. I “Lombardi”,
come venivano chiamati tutti gli italiani del Nord, erano
giudicati dai francesi “vigliacchi e incapaci”.
La Lombardia «era troppo piccola per alimentare un
sufficiente mercato interno di scambio, e troppo debole
per praticare una politica di espansione industriale fuori
dei suoi confini, qualunque fosse l’aiuto dello stato» scrive
Luigi De Rosa, in La rivoluzione industriale in Italia. «Non
molto migliori risultavano le condizioni industriali del Veneto,
e così quelle della Liguria.»
Il Sud fu unito a forza, svuotato dei suoi beni e soggiogato,
per consentire lo sviluppo del Nord. Cominciarono
allora a sorgere fermenti federalisti lombardi: «Quelli che
parlano di uno “stato di Milano”, per contrapporlo al resto
d’Italia» avvertiva Ciccotti, fanno l’errore di credere «che
Milano sarebbe divenuta qual è senza l’unità d’Italia»; e
«hanno bisogno di dissimularsi le vere cagioni del male, per
vivere de’ frutti del mal di tutti, facendo della diversa lingua
o del diverso dialetto e delle diverse latitudini tante ragioni
di dissidi». Vivere de’ frutti del mal di tutti: fare stare
tutti peggio, per star meglio soltanto loro, con la scusa del
federalismo.
Si chiama rubare. Ed era un secolo fa.
Rammento la conversazione con un collega che stimo,
milanese pratico e di successo. Il tema, visto da Nord (lui),
si riduceva a: «Invece di lamentarsi sempre, i meridionali
potrebbero darsi una mossa»; e visto da Sud (me): «Invece
di continuare a spiegarsi il ritardo del Sud con l’insufficienza
dei meridionali, il Nord potrebbe interrogarsi un po’ di
più sulle cause e non crearne di nuove».
Mark Twain diceva che «siamo tutti esseri umani. Non è
possibile essere qualcosa di peggio». Da noi, qualche tentativo
di dargli torto c’è stato. Salimbene da Parma, ricorda
Barberis (Il bisogno di patria), stimava la viltà dei meridionali
congenita, perché «homines caccarelli et merdacoli».
E per uno dei fondatori del Partito socialista, il bolognese
Camillo Prampolini, gli italiani si dividono in «nordici e sudici
». Uno “scienziato”, poi, confermerà la correttezza della
definizione, per «questi degenerati che abborrono l’acqua
in terra e in mare, che non possono giustificare la loro
immensa sporcizia colla immensa miseria in cui il destino li
ha fatti nascere». E si capisce che, fosse stato lui il destino,
non li avrebbe fatti nascere.
Ma il destino non si cambia e persino lo si merita (o no?).
Sorge il sospetto che, dopo aver fatto l’Italia con il furto
e il sangue, bisognava giustificare il modo. «In quegli anni»
leggi in La razza maledetta. Alle origini del pregiudizio antimeridionale,
di Vito Teti «il dibattito sulla razza e sull’inferiorità
del Mezzogiorno venne condotto in una infinità di
saggi, libri, articoli, interventi, a riprova di come esso non
rispondesse a una moda, ma a esigenze conoscitive, cariche
di un’urgenza politica, sociale, culturale.» La “scienza”
lombrosiana (nata da un soggiorno del suo fondatore di soli
tre mesi in Calabria: un genio da far impallidire Darwin)
avrebbe portato alle attese conclusioni.
Così (in ritardo, ché mio padre non mi aveva detto niente:
o non se n’era accorto o volle risparmiarmi una vergogna
di famiglia), appresi di appartenere a una “razza maledetta”;
e seppi che era dimostrata, con «i fatti», l’inferiorità
«razziale, fisica e psicologica, sociale e morale degl’italiani
del Mezzogiorno, rispetto agli italiani del Settentrione».
Facevo veramente schifo e mi era toccato scoprirlo da solo:
era meglio quando, con i soldi di tutti, aprivano scuole solo
al Nord (l’ha fatto qualcun altro, prima dell’apparente
ministro dell’Istruzione Mariastella Gelmini), perché, se i
terroni imparano a leggere, possono farsi del male. Che ne
sapevo io, di essere, in quanto meridionale, parte di una
sottospecie di «degenerati, barbari, degradati, ritardati»?
E, in trasferta all’estero, per emigrazione (e che altro, se del
Sud?), solo «delinquenti»? Persino in presenza di genio,
trattasi di «genialità malata o infeconda» (Pasquale Rossi).
E un’intera regione, la Calabria, riassunto di tutto il Sud,
poteva essere indicata come «luogo di epilettici-degenerati,
di popolazioni superstiziose, tendenzialmente, per caratteri
razziali e temperamento etnico, criminali». Come vi sentireste,
voi, voi euganei, valdostani o brianzoli, o anche solo
marchigiani, persino soltanto molisani, se scopriste una
cosa del genere non prima, ma dopo aver sposato una calabrese
(ignari di indizi rivelatori, quali «la fronte declive e il
diametro bimandibolare accentuato»)? Mettermi in casa
una della regione «più odiata d’Italia»! E la poveretta di
mia moglie mi avrebbe evitato, se avesse conosciuto lo
“studio” che “certificava” (“scientificamente”, e si capisce)
l’ozio, l’indolenza, l’apatia, l’accidia dei pugliesi? Per una
parte non breve della mia vita, mi sono aggirato per questo
paese, inconsapevole della classificazione craniologica, secondo
la quale le teste dolicocefale del Sud erano chiaro
indice di inferiorità, rispetto alle capocce brachicefale che
testimoniavano la superiorità dei settentrionali. Di Borghezio,
avete presente? O Renzo Bossi (tutto papà suo), l’intellettuale
che riesce a diplomarsi in appena quattro tentativi;
dopo di che, per frenare la fuga dei cervelli dall’Italia il
Nord l’ha incaricato di “vigilare” sul sistema fieristico lombardo.
I meridionali, per Massimo D’Azeglio, erano «carne che
puzzava» (la storia tace sul suo alito). Ma si è sempre i meridionali
di qualcuno. Ed è un guaio, perché vuol dire che
chi stila graduatorie finisce in quelle di altri.
E perché si fanno le classifiche, a cosa servono?
A degli studenti-cavia, volontari, si chiese di sopprimere,
pigiando un bottone, esseri viventi, secondo una scala di
prossimità biologica alla specie homo sapiens sapiens. Era
tutto finto: non moriva nessuno; ma loro non lo sapevano
ed erano convinti di uccidere, in un crescendo omicida, microbi,
insetti, invertebrati, pesci, uccelli, serpenti, topi, gatti,
cani, scimmie... Alcuni si fermarono agli uccelli; altri trovarono
intollerabile accoppare gatti o cani, solo per un
esperimento; ci fu chi rifiutò di proseguire solo quando gli
fu chiesto di eliminare le scimmie; e chi eseguì anche quel
comando. Un esperimento analogo fu compiuto con esseri
umani nel ruolo di “vittime”. A studenti-cavie fu chiesto di
infliggere scariche elettriche sempre più pericolose. Erano
fasulle, ma non lo sapeva chi azionò la manopola sino all’ultimo
giro. La scienza, il progresso, la civiltà richiedono
qualche sacrificio, e si trova sempre qualcuno disposto a
farlo fare ad altri.
Anche fra gli esseri umani sono state fatte graduatorie:
schiavi, servitori e padroni; poveri e ricchi; negri, sangue-
misti e bianchi; meridionali, terroni nordicizzati e settentrionali...
Di nuovo: a cosa servono le classificazioni? Gli studenticavia
ci hanno dato la risposta: a stabilire chi deve soffrire
o morire prima, “per il bene di tutti” (cioè di quelli che
hanno deciso a chi tocca prima). Le classifiche sono la giustificazione
necessaria, perché questo avvenga senza rimorso,
“per una buona ragione”. Napoleone Colajanni ricordava
quegli «antroposociologici che, per vedere progredire e
migliorare l’umanità, vorrebbero distruggerne almeno una
buona metà».
Hitler ci provò. Ma quando avviò lo sterminio dei minorati
mentali, la Germania insorse e persino la ferocia nazista
dovette desistere per le proteste popolari. Le vittime designate
erano minorati, ma ariani. Quando si fece la stessa
cosa con gli ebrei e gli zingari, la Germania tacque.
Nella civile Treviso, un sindaco può proporre vagoni
blindati per espellere gli extracomunitari, il loro uso come
prede per i cacciatori locali, la rimozione delle panchine
dal centro, per impedire che siano contaminate da terga extracomunitarie.
E viene rieletto. Ma quando chiude lo stesso
salotto cittadino ai cani domestici (e alle loro deiezioni),
la popolazione scende in piazza e protesta. Nella scala delle
dignità difendibili (o almeno delle sensibilità civili), Treviso
pone i cani (e persino le loro feci, a doverla dire tutta)
più in alto degli extracomunitari. Non è un’opinione; è un
fatto: per Fido si sentirono offesi; per Abdul, non abbastanza.
Le classificazioni sono gradini, indicano la direzione della
violenza che le genera: dall’alto in basso. La quantità di
violenza è proporzionale alla tenuta delle norme del vivere
civile. Se queste si indeboliscono, abbiamo visto con quanta
facilità si passi dalle sparate comico-razziste dell’intellighenzia
balcanica (poco o per niente dissimili da quelle dei
Bossi, dei Salvini, dei Calderoli, dei Gentilini) alla pulizia
etnica. Il mio saggio amico Fulvio Molinari, giornalista e
scrittore, ne ha paura: «Noi triestini l’abbiamo visto succedere
alle porte di casa: chi abusa delle parole viene travolto
dai fatti. Non si rendono conto». E pensate se, invece, se
ne rendono pure conto... Trieste queste cose le percepisce
prima e meglio degli altri, per la sensibilità della frontiera.
Paolo Rumiz si è mosso da lì per il suo viaggio fra le inquietudini
del Nord; e, in La secessione leggera, riporta le parole
di un suo amico di Sarajevo: «Non è stato il fracasso dei
cannoni a uccidere la Iugoslavia. È stato il silenzio. Il silenzio
sul linguaggio della violenza, prima che sulla violenza».
Le scritte «Forza Etna», «Forza terremoto» comparse
nel Nord (e il cui ricordo commuove e inorgoglisce i leghisti
della prima ora, con la memoria degli eroici inizi) celano,
sotto un’apparente esagerazione dialettica, un desiderio
vero, profondo. Un desiderio criminale: a gente a cui il vulcano
distruggeva case, aziende o a cui il terremoto uccideva
i familiari, qualcuno augurava di peggio; e per questo otteneva
voti, consenso sociale. Vergogna per loro; e per chi
consentiva e consente.
Quella violenza è solo verbale, ma va nel senso della
classificazione, perché quando il Po uscì dagli argini, distrusse
case, fece vittime o quando l’ictus paralizzò Bossi,
nessuno al Sud scrisse sui viadotti dell’autostrada: «Forza
Po» e «Forza ictus». La differenza fra le scritte leghiste e
l’assenza di risposta può essere in qualche millennio di storia
in più (magari!), o nell’accettazione del ruolo dei vinti
(più probabile).
L’aggressione leghista ha indotto molti a sentirsi meridionali,
a riscoprire la propria storia; che i settentrionali
preferiscono ignorare, un po’ perché credono di aver già
capito quel che c’è da capire; un po’ perché non gl’interessa
sapere del Sud, che associano a un’idea di cultura inutilmente
contorta, elaborata, improduttiva, perdente e pretenziosa
(insomma, un misto di invidiuzza e disprezzo per
quegl’«intellettuali della Magna Grecia» che sanno un sacco
di cose che non servono a niente); un po’ perché, nella ri-
cerca di radici diverse e distanti, piuttosto che coltivare la
ricchezza delle proprie, si trastullano con la patacca della
“cultura celtica”. Comprensibile la “voglia di passato”, ma
perché forzarne un aspetto per adattarlo a un desiderio del
presente? Si rischia la caricatura, come il kilt, il gonnellino
degli scozzesi, che è un’invenzione folcloristica recente; o il
«sole delle Alpi», quel fiore a sei petali, scelto dai leghisti
quale loro simbolo, ma diffuso da sempre un po’ ovunque,
e abbondantemente nel Mediterraneo: era già sugli scudi
dei guerrieri di Puglia (però zona-Nord, eh?), più di tremila
anni fa. Sciur Asterix de la Briansa, quello è il sole del
Tavoliere! Ch’el vaga schisc anca (Ci vada piano pure) con
l’avo barbarico: al Nord lasciò il nome a una regione, mentre
al Sud i suoi stati e le sue leggi nei tribunali sopravvissero
ancora per quasi tre secoli, e con tale forza ed estensione
(parte della Campania, della Basilicata, della Puglia e
della Calabria) che, nelle mappe dell’epoca, la “capitale di
Longobardia” era Bari. Terun! Ma questo libro parla della
costruzione della minorità del Mezzogiorno, così, tanto vale
dirlo subito: il pur più duraturo stato meridionale di quei
barbari che vennero a civilizzarsi in casa nostra passò alla
storia con il nome di “Langobardia Minor” (e te pareva!).
«Quando non si vuol fare qualcosa per capirla,» ha scritto
Marco Paolini «si trasforma la storia in geografia.» E accettiamo
che, contro il valore dei fatti, la geografia divenga
comunque vincente, se segna Nord e comunque perdente,
se segna Sud? E che la latitudine misuri il valore degli uomini,
delle loro azioni, dei loro diritti? Ma non è esattamente
questa l’essenza unica, piena, del razzismo? Non è nella
facilità di tale promessa il suo successo con gli stupidi e gli
egoisti?
«Le identità plurali sono percepite dai nazionalismi come
altrettante minacce» scrive Predrag Matvejevic´ in Mondo
ex e tempo del dopo. E spiega che è proprio nelle «nazioni
venute tardi», come l’Italia, che «queste malattie di
identità» colpiscono più facilmente.
Il Settentrione ne patisce, perché scellerate scelte politiche
ed economiche hanno (de)portato al Nord alcuni milioni
di meridionali, con i loro dialetti, le loro diete, le loro
abitudini. Per quanto essi abbiano cercato di assimilare
nuovi accenti e costumi, i propri hanno influito su quelli altrui;
sapori e amori si sono fusi, generando un meticciato
avvertito come minaccia per l’identità del Nord. La Lega,
l’invenzione di riti celtico-padano-veneti sono furbate politiche
per trasformare in voti il bisogno di riscoprire radici
e armarle di razzismo («Decidemmo di sfruttare l’antimeridionalismo
diffuso in Lombardia, come in altre regioni del
Nord» ammette lo spudorato Umberto Bossi nel Mein
Kampf della Lega, il suo Vento dal Nord).
E ne patisce il Sud, che ha meglio conservato il colore
delle radici (indebolite dall’esodo, ma non stemperate da
tradizioni diverse), pur se nei comportamenti è stato indotto
a rinnegarle, a ritenerle superate, scadenti, sconfitte. Come
per gli ebrei convertiti a forza, gli è toccato sentire in un
modo e agire in un altro. Finché, col tempo e le generazioni,
quel sentire si è fatto flebile; salvo riaccendersi, per l’offesa,
e proporsi “contro”.
La tardiva scoperta di essere meridionale mi ha rivelato
un assurdo: i meridionali traggono il nome da quel che gli
manca: il Sud. E pure quando la geografia gliene offriva
uno (le infelici avventure contadine dei siciliani in Libia, in
Tunisia), la storia glielo ha negato. Il mondo dei meridionali
ha una direzione in meno: più giù di dove sono non si
può andare, restando “a casa”. Il Sud porta con sé un’idea
di gioia e di nostalgia; se la prima è data dal clima, dalla natura,
l’altra (come accade, a volte, dopo un’amputazione)
viene dal dolore dell’arto fantasma: fa male quello che non
c’è. Il Sud. Ed è una negazione pesante.
L’estremo lembo di alcune regioni, che il sentimento proprio
e altrui percepisce “al confine del mondo”, è chiamato,
in Galizia come in Cornovaglia o in Bretagna: Finisterrae. In
Italia un posto così è in Puglia, a Santa Maria di Leuca: lì il
mare si alza come un muro, a chiudere il discorso. La Puglia
è un dito di terra lungo quasi quattrocento chilometri,
ma largo poco più di trenta, verso Leuca. Significa che non
solo ci manca il Sud (Finisterrae), ma altre due direzioni,
l’Est e l’Ovest, sono appena abbozzate. Si intuisce altro, da
qui, a cui non pensi se hai intorno un orizzonte completo e
percorribile. Può trattarsi della direzione negata della vita.
Un settentrionale può volgere gli occhi e cercarsi il futuro
in ogni parte. Un meridionale, no: è costretto a guardare
solo verso Nord: dalla storia, dall’economia figlia di quella
storia, e persino dalla geografia. In realtà, nemmeno il settentrionale
ha davvero scelta; se rinuncia al Sud, come
quattro scriteriati vorrebbero, cade nella nostra condizione
(ma in modo artificioso, falso, quindi sterile): quella degli
amputati. Mentre a noi tocca un arto fantasma che ti
rende fertile (perché non è la tua volontà a privartene), a
prezzo di un dolore necessario: chi non raggiunge e comprende
Finisterrae (la parte che manca) non sa il suo limite,
non sa quel che vale. E si vede.






.jpg)