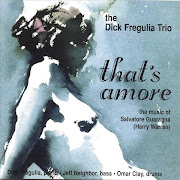Ricevo e posto:
Di Lucio Garofalo
L’art. 1 della Costituzione italiana recita: “La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”. Parole sacrosante. Ma la sovranità popolare è di fatto negata o limitata da una sorta di assolutismo mediatico, una strisciante dittatura ideologica generata dalla televisione. Una tirannide che Pasolini aveva raccontato come il vero fascismo, cioè la peggior forma di oppressione totalitaria.
Il potere di persuasione occulta della televisione è immenso, subdolo e penetrante, è un dispositivo ideologico pervasivo e monopolizzante, funzionale ad un disegno di autoconservazione e rafforzamento dell’ordinamento vigente. Oggi, più che mai, si rivela in tutta la sua sconcertante verità un principio sacro al ministro della propaganda hitleriana, Joseph Goebbels, il quale sosteneva (non a torto) che una menzogna ripetuta ossessivamente, prima o poi viene recepita dalla gente come un dogma incontestabile.
In altri termini, non si inventa nulla di nuovo, ma si tratta di un fenomeno addirittura elementare e primitivo; tuttavia cambiano le soluzioni e le forme, le strategie e i mezzi tecnici, ritenuti più utili e convenienti, soprattutto adeguati all’attualità del momento.
Il sentimento immediato e primordiale su cui agisce e si impernia l’apparato ideologico della (dis)informazione televisiva, è la paura, ossia l’inquietudine suscitata negli animi di fronte ad una presunta “minaccia” (reale o immaginaria che sia, poco importa) descritta e agitata come uno spauracchio capace di influenzare e mobilitare le masse.
La paura è il fulcro istintivo ed emotivo su cui fa leva la macchina propagandistica della “strategia della tensione” ed è un formidabile strumento di controllo esercitato nei confronti dell’opinione pubblica. In passato si faceva ricorso al “nemico” individuato, in base alle circostanze e alle necessità, nel terrorismo di tipo interno (di matrice brigatista o di altra provenienza) ed esterno (come ad esempio al-Qaida o altre sigle internazionali), ovvero nel pericolo rappresentato da un’epidemia sconosciuta (si pensi all’Aids negli anni ’80, o altri morbi contagiosi, come in epoca medievale la peste nera) o altre infezioni di origine alimentare (cito i casi noti della mucca pazza e dell’aviaria).
Il meccanismo psicologico irrazionale innescato da chi detiene il potere, è una modalità di sorveglianza e di pressione sociale adatta a scatenare fenomeni di panico collettivo e isterismi di massa, creando ad arte un contesto di allarmismo diffuso che permette di giustificare interventi destabilizzanti e svolte politiche di segno autoritario e repressivo.
Oggi si preferisce impiegare le armi più sofisticate e “sublimi” della guerra finanziaria.
Mediante un bombardamento incessante e quotidiano, i mass-media agitano lo spettro terrificante dello “spread” o del “default”, in modo che l’opinione pubblica di una nazione sia messa nella condizione di accettare anche la soluzione più estrema e dolorosa. Si pensi al clima di “emergenza nazionale” provocato in modo puntuale da chi mira a legittimare e cavalcare “rivoluzioni” antidemocratiche che si inseriscono in un piano di ristrutturazione economica e ricomposizione del capitalismo su scala globale.
Si tratta di una piattaforma aggressiva e agguerrita, di impronta oltranzista ed eversiva, egemonizzata dalla borghesia imperialista ed imperniata sulla costruzione di un governo presieduto da un tecnocrate, che evidentemente fa comodo a quei centri di potere che invocano e perseguono misure drastiche e draconiane contro la crisi, per scaricare gli effetti più duri sui lavoratori e cancellare in un colpo solo le tutele sociali e i diritti sindacali conseguiti dal movimento operaio attraverso decenni di lotte tenaci e costanti.
Con l’incarico conferito dal Quirinale al professor Mario Monti, un tecnocrate promosso senatore a vita, si è insediato un governo ultraconservatore appoggiato e sponsorizzato dalle principali forze parlamentari di destra e di “sinistra”, che formano un fronte compatto al servizio del capitale quando si tratta di salvaguardare gli interessi dei gruppi economici dominanti. L’esecutivo di “emergenza” nato sotto la pressione dei mercati borsistici si rivelerà persino più reazionario e antipopolare di quello guidato da Silvio Berlusconi. Per la serie: “dalla padella nella brace”. Ce ne accorgeremo presto.
Per introdurre un regime dittatoriale non serve più il ricorso alla violenza militare, ma è indubbiamente più efficace l’autorità morbida e persuasiva esercitata dalla televisione.
Non a caso, se un colpo di Stato è attuato direttamente dall’esercito, si definisce “golpe militare”, ma se è il potere delle grandi banche a sovvertire (o a condizionare, che dir si voglia) in modo astuto e capzioso le istituzioni democratiche, consolidando il primato della finanza sulla politica, si preferisce chiamarlo ipocritamente “governo tecnico”.
L’esperienza storica insegna che un governo cosiddetto “tecnico” riesce più facilmente (e abilmente) ad imporre all’opinione pubblica quei rimedi percepiti come impopolari e coercitivi, diversamente da un governo eletto democraticamente, che è più sensibile alla volontà di estendere o, in ogni caso, mantenere la base del consenso elettorale.
L’arroganza e la spregiudicatezza del capitale finanziario sono tendenze apertamente ostili alle istanze di partecipazione e democrazia rivendicate dal basso, ed oppongono un baluardo insormontabile che ostacola ed impedisce l’esercizio della sovranità popolare.
Si riconferma l’antitesi assolutamente insanabile che esiste tra i mercati azionari, da un lato, che rispondono solo alla ferrea, spietata e disumana legge del plusvalore, e le regole o i valori essenziali di ogni forma di convivenza civile e democratica, dall’altro. Si tratta di una situazione di inconciliabilità conflittuale e di irriducibile contrapposizione, intrinseca alla natura autentica e all’origine stessa del capitalismo, inteso tout-court.
.
Perché utilizzare un data center
-
Il data center è fondamentale per il business di ogni azienda, ospita le
principali apparecchiature che permettono di gestire le comunicazioni, i
processi ...
1 anno fa













.jpg)