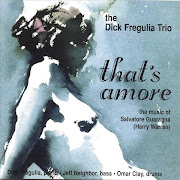Di Nicola Zitara
Il presente saggetto è il fedele rifacimento (o piuttosto riordino) di uno scritto risalente a qualche anno prima delle elezioni regionali del 1985, forse al 1982 o 1983, il quale ebbe il singolare destino di non trovare spazio sui Quaderni calabresi. Non fu questo, tuttavia, il solo motivo per cui è rimasto per tanto tempo nel cassetto. Per chi pretende di scrivere storia del Sud italiano, relativamente all’infelicissima fase unitaria, che non sia la solita "Storia della questione meridionale", la difficoltà maggiore sta non tanto nell’organizzare i materiali per una Controstoria, quanto nel cogliere con onestà intellettuale le cose che potevano essere -in un paese veramente appartenente allo Stato italiano- e che invece non sono state, a causa della pesante colonizzazione toscopadana. Certamente la questione della borghesia meridionale appartiene a tale tipo, quasi impossibile, di storiografia. Da qui una forte resistenza personale a ricalarsi come storico nel tema. Il quale, tuttavia, veniva affrontato a livello di scontro politico locale (e quindi nel suo aspetto attuale), attraverso il Volantino (quattro pagine ciclostilate). La tematica de il Volantino anticipò di sei o sette anni Tangentopoli. La contestazione morale ebbe una forte risonanza locale, ma non superò tale perimetro, tranne che per gli aspetti giudiziari. Si ebbe, infatti, un processo, ma solo per diffamazione a mezzo stampa, tenutosi parecchi anni dopo -ma sempre parecchio tempo prima che esplodesse Tangentopoli- davanti al Tribunale di Monza, il quale ribadì il diritto (anzi il dovere) di critica al costume politico. Adesso la riformazione delle cosche ridà attualità al tema, così che il risultato della riflessione di allora viene offerto a un pubblico si spera più vasto.
IL SISTEMA DI POTERE IN MERIDIONE - DAI GALANTUOMINI ALLA CLASSE INFAME
Baroni e galantuomini
Pur essendo una figura tipica dell’Italia unita, in quanto strettamente collegata con il sistema elettoral-accosciato, con l’ascarismo unitario, il galantuomo meridionale nasce prima che Garibaldi e Cavour depistino la storia del Sud. Indubbiamente nasce dalla terra. Anche la fatua gentry inglese nasce dalla terra, ma non per questo riesce a rovinare la Gran Bretagna. Il problema pertanto non sta in essa (quantomeno alle origini), ma nel modo in cui si formano le sue entrate. Nella storia del Sud, la svolta modernizzante è il frutto di due concause: da una parte, la crescita della domanda mondiale di zolfo e di olio, in connessione con l’ultima fase -una fase fortemente espansiva- della manifattura e con la prima Rivoluzione industriale; dall’altra, la fine della dominazione spagnola e l’avvento nelle terre napoletane e in Sicilia di uno stato indipendente, sia pure sotto la guida di una dinastia proveniente da fuori e pensosa di sé stessa, prima che della nazione.
Come ha insegnato Kula, anche un’economia chiusa -non più che un’economia di villaggio- può ben convivere con il commercio mondiale. Ora se il monopolio dello zolfo rese ben poco alla Sicilia e il commercio lecito o illecito dei grani non vi ebbe quel peso sociologico che la saggistica posteriore ha creduto d’intravedere, la parte continentale del Regno ebbe consistenti benefici dagli scambi continentali. Infatti, quando la dinastia borbonica chiuse il suo bilancio, il paese napoletano si trovava con l’aristocrazia debellata, con abbondante risparmio, con le attività commerciali interne, alle quali si dedicava una potentissima flotta di dodicimila navi piccole e grandi, ben sviluppate. Era inoltre il beneficiario del quasi-monopolio mondiale della produzione d’olio, una merce richiesta dai maggiori paesi industriali come alimento, per l’illuminazione, come lubrificante dei motori e materia di lavorazione del cotone. Non suoni strano, ma nei fatti la rinascita commerciale aveva aiutato il baronaggio ad affermarsi.
Il feudalesimo è una condizione giuridica, propriamente di diritto pubblico, mentre il baronaggio del XVIII, XIX e XX secolo è una condizione dello spirito, oltre che un modo di rapportarsi alla società. Nonostante assuma atteggiamenti neofeudali, il barone è giuridicamente pari a qualunque proprietario secondo il restaurato diritto civile romano (cioè con la piena facoltà di godere e disporre della cosa). Già nel secolo dei lumi, l’aristocrazia napoletana è un nome senza gran sostanza. Lo stato ha carattere patrimoniale e gli aggregati urbani hanno egemonizzato le terre circostanti. Il circuito intercorrente tra castello, palazzo nella capitale e sperpero delle rendite si è fortemente indebolito e subisce la mediazione del borgo. L’altro circuito, non meno pesante, quello delle esternazioni, che va dal villaggio rurale alla corte spagnola, è fortunatamente chiuso. Il lavoro evolve verso una nuova forma di produzione e la città si va separando dalla campagna. Il più solido momento di congiunzione resta il proprietario inurbato -principalmente lui, il barone1, il primo proprietario del luogo, che domina la campagna e spadroneggia in città. In campagna, la miseria e l’ignoranza delle masse contadine gli offrono il destro di pretendere e d’ottenere, pur senza averne titolo, un rispetto del tipo feudale; in città, per quanto possa essere arcaica la sua azienda agricola, il solo fatto che essa sia la principale sede locale di produzione, porta chi la dirige in contatto con il lavoro urbano e con i civili attivi, fino a dominare l’uno e gli altri con autorevolezza, appunto, baronale.
Mentre la rendita feudale si decompone in forza dei processi che il mercato innesca, è proprio la vivacità mercantile dell’olivicoltura che rafforza la posizione aristocraticante del nostro parvenu. Beati monoculi in terra caecorum. Il proprietario d’oliveti non ha pari in altri settori, cosicché il grande produttore d’olio, il barone, nella sua albagìa e nella sua ignoranza, può credere che il flusso di benessere proprietario che l’esportazione gli porta, quasi un grazioso dono di Dio, non si esaurirà mai. A questa idea contribuì sicuramente la mano leggera, in materia fiscale, con cui i Borbone trattarono sempre i settori vocati all’esportazione, tanto più che si potevano facilmente rifare con il consumatore straniero, gravando l’olio d’un dazio all’uscita. Ancor più fortemente dovette contribuire il basso costo d’impianto. L’ulivo è una pianta divina che non richiede cure, ma solo dei tempi d’attesa e una certa vigilanza nei confronti dei pastori, delle greggi e delle mandrie. Basta sistemare una piantina nel terreno perché cresca da sola. Dove le terre sono appoderate -cioè quasi sempre- il contadino può continuare, nell’interfilare, le sue tradizionali coltivazioni di cereali, ortaggi, legumi. Tuttavia non è la posizione di agricoltore il tavolo anatomico su cui sezionare la figura baronale, ma quella sociale e politica. Il barone è barone in quanto ha una regolare entrata in ducati, la quale viene prevalentemente dalla produzione dell’olio. Questi non ha una cultura sufficiente per immaginare che l’espandersi del mercato farà crescere i suoi bisogni e che un bel giorno le sue entrate si riveleranno insufficienti. Quindi arriva molto tardi a reinvestire le sue consistenti rendite. Non sente il bisogno di crescere, non ha appetiti animaleschi, ma, per altro verso, non vuole perdere niente, così non ama dividere con fratelli e sorelle, e finché può, si aggrappa alla legge del maggiorasco. Ma, con il declinare del feudalesimo e delle rendite ecclesiastiche, i fratelli minori trovano una collocazione sempre più difficile. Nasce, così, una questione, che, se parlassimo la lingua occitana, chiameremmo dei cadetti. Non che qui mancasse qualcuno da sbudellare, ma i Borbone andavano cauti con le spese di corte, e quanto ai moschettieri preferivano importarli d’oltralpe. Così che i nostrani cadetti restavano in casa a consumare la verginità delle serve.
Barone il fratello ricco, barone il povero fratello, o se più vi piace, il fratello povero. I fratelli baroni si amano come tutti i fratelli, e tranne che la terra e le rendite (che fanno la baronia), il barone ricco darebbe tutto al barone povero. E infatti gli cede parte della sua ignoranza, una quota della sua arroganza, e gli lascia intero lo spirito di rivalsa. Infatti il cadetto meridionale partecipò entusiasticamente alla rivoluzione del 1799, nella speranza che questa moltiplicasse le terre appropriabili, togliendole agli aristocratici più testardi, ai comuni e alla Chiesa, cosa che i Borbone mai vollero fare.
Il galantuomo nasce nel sottoscala proprietario e baronale del paese e della città meridionale, nella fosca alba di un giorno che per il Sud sarà più tetro della buia notte. È un cadetto della famiglia con scarse rendite, o è lo stesso barone decaduto, o il figlio del massaro che ha fatto la salita finché il padre lo ha sospinto, ma che, morto il padre, non sa salire da sé. Non è il proprietario arricchitosi che un giorno potrebbe diventare barone e che già si comporta quasi come se lo fosse. No, il galantuomo con la ricchezza ha chiuso, dopo non avere mai aperto. Se per caso ha qualche terra, non ne ha a sufficienza per vivere da barone. Insomma il cadetto sudico è un barone disarcionato, il quale non incontra nella sua parabola sociale un re guerriero che lo innalzi a cadetto di Guascogna, né una Chiesa in espansione che ne faccia un pingue abate, né un ricco mondo mercantile che gli prometta un altro tipo di corona.
Con i Borbone, i galantuomini sarebbero periti socialmente, come in tutti gli stati moderni, confusi nella piccola borghesia impiegatizia, dei commerci e dei servizi. Sopraggiunti i Savoia, i galantuomini ebbero invece il modo di intossicare la società meridionale. I fatti stanno a dimostrare che il vero disegno unitario non consisteva nel dare un governo moderno al Napoletano e alla Sicilia, secondo l’aspirazione risorgimentale, ma nel mungerne l’agricoltura per salvare dalla bancarotta la corona sabauda, che ora ammorba con puzzo di cadaveri e di stallatico l’intera Italia. Per qualche spicciolo e qualche medagliere, i galantuomini si prostrarono, offrirono il fondo del dorso, furono gli ascari della colonizzazione.
Fatta l’Italia, bisognava fare chi la mantenesse. Nel generale lutto per il crollo del prezzo della seta, nasce la modernizzazione nordista. I De Ferraris, sedicenti Galliera, i Bastogi, i Balduino, i grandi profittatori e intrallazzisti della cerchia cavourriana, fondano la patria finanza e il capitalismo italiano (padano) violentando la vergine Italia ancor prima che fosse condotta al fonte battesimale. Non sono dei ladri puri, tipo Grisby ma propriamente dei capitalisti che imparano il mestiere di truffare lo stato da coloro che intorno a Napoleone il Piccolo stanno facendo una grande cuccagna con i franchi del contribuente transalpino. Non rubano i nostri fondatori, ma spingono lo stato sabaudo, cavourriano e liberale a questa o quella attività, che loro, e solo loro, avranno il privilegio d’intermediare, lucrandoci lautamente sopra (sui titoli del tesoro, che spesso comprano con i soldi dello stesso tesoro, arrivano a lucrare 79 lire su 100).
Ovviamente le operazioni sono più facili nei territori a loro noti, così che si comincia da Genova e da Torino, poi si passa a Firenze e in appresso si scende a Roma. Nel frattempo Milano, Bologna, Padova, Ferrara, ecc. pretendono di non restare fuori. Anche Napoli, alcuni decenni dopo, chiede e ottiene qualche intervento lucratorio. Anche Palermo chiede, ma per ottenere quasi niente. A Napoli manca un capitalismo di buon appetito, sostiene la storiografia sabauda con il plauso dei sedicenti storici gramsciani. Il fatto che vi operi persino uno dei tre fratelli Rothschild, i veri padroni d’Europa, non conta niente per i nostri rapsodi. A fare il confronto con il piccolo regno sardo, quel che in realtà manca non sono gli impianti industriali portanti della futura nazione industriale; la cosa che a Napoli manca è lo sfacciato intrallazzo cavourriano e postcavourriano che, a partire dal 1853 e fino a quando Giolitti non chiuderà la bocca ai più impertinenti, con l’aiuto dei soliti prefetti e corrompendo con la sua generosità i socialisti dell’Emilia rossa, riempirà decine di volumi degli Atti Parlamentari. Nonostante il passaggio epocale, il Regno borbonico vive una condizione di tranquillità e di serena fiducia. Nel campo economico è reputato e si ritiene una potenza di rango. Anche sul lato industriale è limitativo metterlo a confronto con gli altri stati della penisola. Il Regno ha un’autonomia che gli altri, a cominciare dal Piemonte sabaudo, sono ben lontani dal possedere. Nei settori strategici dell’industria, vale a dire la siderurgia, la meccanica e la cantieristica, essi hanno bruciato i tempi naturali di maturazione economica, facendo in proprio. E se cadono sotto i colpi di Garibaldi e dei generali sabaudi, è perché non intendono sistemare i parassiti sociali.
Possiedono le risorse per avviare l’industrializzazione privata, dopo avere fondato quella pubblica, e pertanto non allettano intrallazzisti. E ciò sarà fatale per il futuro del Sud, che fino alla Cassa per il Mezzogiorno non avrà il personale idoneo, la cultura, per partecipare in grande alle patrie dissipazioni. Invece che grandi ladri, o dei ladri in grande del tipo Bastogi, Balduino, Breda, SME, Fiat, il Sud avrà dei ladri di polli. Anzi qualcosa di meno, perché i contadini dispongono, tutt’al più, di una minestra di broccoli. Che i galantuomini non si vergognano di arraffare.
In sostanza, il Sud contribuisce all’intrallazzo nazionale dal lato delle uscite, ma non ricava niente dal lato delle entrate. È terra infidelium per gli intrallazzisti toscopadani. Che il Sud non sarebbe mai divenuto una vera parte del paese, ma un mero mungitoio cavourriano e sabaudo, lo si era visto già prima che cominciasse, non appena il plenipotenziario cavourrista Farini arrivò a Palermo. A Torino le idee erano chiare. L’assenso delle classi proprietarie sudiche ce lo procuriamo difendendo la proprietà; quello delle classi medie, lottizzando a buon prezzo i beni ecclesiastici, di cui per altro (noi torinesi) incasseremo il valore; quello dei proletari, offrendo una speranza di lottizzazione sui demaniali comunali. Ma i contadini avevano una fame antica. Raggirati sulla questione della terra, scatenarono il brigantaggio politico costringendo il governo liberale a rinsaldare la sua alleanza con i galantuomini -ironia degli aggettivi- anch’essi liberali. Se i piemontesi fossero arrivati dall’Alaska sarebbero stati meno stranieri a questo popolo.
Mungere i sassi
La Rivoluzione industriale ha inciso così profondamente sugli assetti tradizionali da mettere il mondo su nuove gambe, purtroppo storte fin dal primo momento. Guidata da logiche irrazionali, l’economia mondiale ha due volti: quello di un mondo che progredisce e quello di un mondo che regredisce. In Italia, la contropartita più devastante si ebbe proprio nelle campagne del Sud, dove alla restaurazione del concetto romano di proprietà, che aveva decretato la fine dei diritti promiscui, si aggiunsero forme moderne di conduzione, del tipo risparmia-lavoro. Per l’ancestrale colono fu la fine. I contadini vennero scacciati a milioni dalle campagne. D’altra parte la regolarità del salario li attraeva lontano dai campi, in un lavoro sentito sì come alienante, ma anche come fonte di un pane sicuro. Ma non fu solo questo. Dove l’industria non nacque (come nel Meridione), i prodotti industriali arrivarono comunque, spazzando via l’antica industria domiciliare dei contadini. L’arrivo delle merci industriali prodotte altrove, sottraendo ai contadini l’antico lavoro manifatturiero, fece sì che l’unica fonte da cui ricavare un guadagno rimanesse la terra. Si deve aggiungere che, a partire dal 1650 circa, la popolazione d’Europa prese a crescere a un ritmo senza precedenti, raddoppiando nel corso dei duecento anni successivi e facendo il doppio tra il 1850 e il 1930. Nelle aree non industriali, la bassa capacità d’acquisto sommandosi alla pressione demografica portò le masse contadine a rivivere una condizione vicina all’economia di sussistenza.
Tutta la grande narrativa meridionale è confezionata con il dolore di quell’epoca infelice. Dopo essere stati consumatori soltanto dei propri prodotti, una volta divenuti consumatori di lavoro altrui, i contadini presero a mungere la terra nella vana speranza di cavarci il danaro per vivere. In regioni come la Puglia e la Calabria si misero a cultura persino le pietraie, nella vana illusione di mungere dai sassi quello che i sassi non danno.
Mentre l’Europa industriale arricchisce, il Meridione -ormai spoglio di risparmio privato e privo di uno stato che lo guidi- vede spegnersi le sue manifatture e la grande industria statale borbonica. L’occupazione nel settore manifatturiero cala, in venti ani, da oltre il 18% a poco più del 12% delle persone in età lavorativa2. Si dice la stella d’Italia. Ma solo del Nord. Nonostante la crisi da cui è investito, la particolare condizione climatica e la positiva eredità borbonica aiutano il Sud a compiere l’ultimo miracolo -un miracolo, ovviamente, tornato interamente a favore del paese settentrionale. Stava mettendosi male per i Savoia e per la cosca piemontese. Crollata la seta e crollate le speranze riposte dai conquistatori piemontesi sulle regioni seriche, l’olio diviene il primo sostegno della bilancia commerciale unitaria. Ma subito dopo, accanto all’olio si allineano altri prodotti tipici, quali il vino e gli agrumi. Diversamente dall’ulivo, questi impianti richiedono un investimento di capitali. Ma, in appena qualche anno, il Piemonte ha interamente incassato e dissipato l’accumulazione storica napoletana. In più si cucca ogni forma di surplus che si formi al Sud. I proprietari, vessati dal drenaggio fiscale, non hanno risorse adeguate. E tuttavia il miracolo si compie egualmente, frutto del sudore e dell’intelligenza contadina. Olio, arance, vino, fichi secchi -povere cose di un mondo al passato- sono tutto quello di cui dispone l’Itaglia. Ma lo stato di Sella e di Minghetti le fa bastare. Così è il Sud che paga praticamente da solo la tripla speculazione ferroviaria: quella delle concessioni, quella della prima nazionalizzazione e quella della successiva privatizzazione. Paga inoltre alla Francia il debito estero ereditato dal Regno di Sardegna e quello alimentato dall’allegra gestione della Destra -severa solo con i contribuenti- salvando in tal modo due volte lo stato nazionale dalla bancarotta.
Certamente nel mondo attuale nessuna produzione agricola risulta vincente alla lunga distanza, in quanto l’offerta degli agricoltori cresce più della domanda dei consumatori, deprimendo il prezzo. Nello stesso tempo, i prezzi delle merci industriali, che si strutturano indipendentemente dalle vecchie leggi di mercato, incorporano di regola elementi di monopolio, che con l’andar del tempo si faranno sempre più consistenti. Si realizza così un particolare squilibrio delle ragioni di scambio che, nei grandi aggregati economici tipo CEE, oggi viene sanato soltanto attraverso costose forme di protezionismo doganale.
Comunque nel Sud italiano non fu il mercato a mandare a gambe all’aria la rivoluzione agricola in corso, ma lo stesso stato, cosiddetto italiano, attraverso un ribaltamento della precedente politica filofrancese e liberista con un’incredibile alleanza austrotedesca e l’adozione di un autolesionistico protezionismo doganale; cosa pretesa -e ottenuta con la corruzione- dalla Banca Commerciale, dai suoi finanziatori tedeschi e dai neo-intrallazzisti milanesi che, atteggiatisi a industriali nazionali, continueranno per ben settant’anni a corrompere i governi nazionali per aver mano libera con i consumatori nazionali. A disdoro di Lor Signori Cuccatori e dei paladini del Corriere e delle case editrici nazionali, ben remunerati assertori del "Sud che non produce", è il caso di ricordare che, nonostante le loro albagìe, i salotti buoni e altre immonde incensature, gli agrumi resteranno la voce più importante del commercio internazionale italiano fino al 1955 circa.
Mentre l’erario nordista impone la feroce formazione di surplus da astinenza che poi drena immancabilmente verso l’intrallazzismo toscopadano e ora anche capitolino, ogni speranza muore nel cuore dei generosi e degli intrepidi. L’Italia colonialista, che, al Sud, emargina gli onesti e i patrioti3, può trovare un sentito sostegno soltanto in una classe infame, del tipo Quisling e quinta colonna: la classe dei galantuomini -classe italiana per eccellenza, che tenne il potere fino al 1943 e rinacque a partire da De Gasperi con stile e tono ben diverso.
L’epoca dei galantuomini
Dovunque è nata l’industria, l’aristocrazia di origine agraria ha perduto la direzione della società di appartenenza. Dove l’industria invece non nacque, le classi superiori e proprietarie si sono arroccate intorno alla proprietà terriera4. Dove anche l’agricoltura è stata cancellata, la borghesia dovrebbe essere alla testa di un moto di rinascita.
Il sistema italiano ha sempre saputo evitare tale insidia. Infatti, nell’assenza di remuneratività in altre attività, il nostro sistema ha incanalato la competizione fra borghesi del Sud nell’ambito dell’attività pubblica: sia quella politica in passato onoraria, sia propriamente burocratica e remunerata. Anzi tra l’una e l’altra si generò un sistema osmotico, per cui il politico onorario di grado elevato (ministro, sottosegretario, deputato) fu sostenuto da un gruppo di aderenti (consorteria), i quali sarebbero stati ricompensati con impieghi e prebende -una forma di sistemazione pseudo borghese, imitativa cioè del prestigio e della condizione sociale della borghesia danarosa. L’impiego divenne l’"occasione" per eccellenza, l’unico modo per evitare la totale caduta sociale, una completa proletarizzazione. Ma l’accesso all’impiego non dovette essere facile. La ricerca storica dovrebbe proprio chiarire tale punto. Comunque possiamo dire che intorno al "posto" si accese in passato, come si accende nel presente, l’unica reale competizione infraborghese a cui si assista nel Meridione. La consorteria, nata dal basso, fu l’SOS di una classe sociale vinta ai suoi esponenti più fortunati e potenti5.
Collocando il Meridione dell’epoca -cioè la parte del paese che accumula senza ottenere altra spesa pubblica se non quella del danaro della corruzione- nel quadro delle cose che potevano essere e non sono state, lo spaccato che se ne ricava non è "la questione meridionale" oppure "il ritardo storico". L’eredità spagnola e il mancato coinvolgimento nella rivoluzione comunale c’entrano ben poco. Il nodo è tutto economico ed è tutt’interno al mondo industriale, cioè dell’epoca nostra. Il tema giusto è l’accumulazione originaria dell’industria padana6, che ha avuto bisogno, per compiersi, di un vasto popolo di contribuenti e di un intero secolo: dal 1860 al 1960. Rispetto a detto tema, i galantuomini furono, a volte inconsapevolmente, gli agenti nazionali dell’accumulazione primaria padana, realizzata per una quota preponderante e forse superiore all’80% ai danni dei contadini meridionali e degli emigrati meridionali.
L’intramontabile epoca dei galantuomini fu contrassegnata non solo dal progressivo, ulteriore impoverimento delle classi agrarie (che ha il suo finale travolgente nel protezionismo fazioso della CEE), ma soprattutto dall’apertura dei ranghi del pubblico impiego alla borghesia, spesso ignorante, del Sud. In origine, i beneficiari appartenevano ad una classe bloccata, imbalsamata nella staticità di rapporti economicamente regredienti, anche a causa della crescita numerica dei componenti, a sua volta frutto della generale crescita demografica. Ridotti in miseria dallo stato che essi stessi avevano adottato, battuti dagli scambi diseguali con le società industriali, impossibilitati ad aprirsi nuove strade, quando potevano si rifacevano sui contadini, che erano il loro antagonista sociale interno e peraltro vincibile soltanto con l’aiuto delle piumate milizie padane. Ma il soccorso più consistente gli arrivava da una certa libertà a truffare lo stato, specialmente in sede di amministrazione comunale. Gaetano Salvemini ci ha lasciato un impareggiabile ritratto politico della loro storia più antica. Luigi Pirandello -pur puntando ad altra tematica letteraria e filosofica- ne descrisse con vigore insolito, specialmente nelle "Novelle per un anno", i loro drammi, la loro meschinità, la loro fragilità, la loro miseria materiale.
Il progresso -anche quello esterno soltanto- provoca forte mobilità sociale, e l’epoca dei galantuomini fu di nuova e notevole mobilità sociale. Ad un certo punto, già prima della Grande Guerra, ma anche dopo, specialmente sotto il fascismo, i galantuomini ebbero un sostenuto rinforzo con l’iniezione di dottori e diplomati saliti dalle classi proletarie. Ma nulla cambiò, la classe indegna sopravvisse attraverso l’elargizione del "posto" che lo stato creava ambiguamente: sia perché si perfezionava come stato centralizzato e burocratico, sia perché inventava surrettiziamente "posti" in soprannumero per tenere in piedi il sistema. In effetti il Ministero della malavita di salveminiana memoria governò le elezioni dei deputati meridionali con i prefetti e fece ingoiare al Meridione la corrispondente soperchieria perché il sistema ebbe sempre nuovi posti da distribuire.
Da un punto di vista politico nazionale, l’identità sociale -il particolare status- del galantuomo è quello di mantenuto e contemporaneamente di sostegno del sistema nazionale. All’interno di tale settore sociale si sviluppò una forte competizione che vide la formazione di gruppi fra loro contendenti, aggregati dalla solidanza dell’imbroglio amministrativo, dallo scrocco nella gestione pubblica, nella feroce negazione di uguali opportunità al gruppo contrario. Da questa negazione prende avvio e si sviluppa la degenerazione dell’intera società meridionale, la sua corruzione ormai interiorizzata, il disvalore dell’onestà pubblica, appena compensato, qualche volta, dall’onestà privata, l’ambiguità, peraltro non più attuale, tra "spirito di servizio" e assurda e completa inefficienza, la cedevolezza sui grandi principi e la rigidità formalistica, più spesso opposta ai deboli e alle fazioni contrarie che all’interno della consorteria.
Fascismo e consorteria
Il destino della "consorteria" sotto il fascismo non credo sia stato spiegato con la doverosa onestà. Il regime portò nella statica società meridionale una contestazione a destra e una a sinistra. Da quest’ultimo lato, esso operò in difesa della proprietà agraria spingendo le prefetture e le forze di pubblica sicurezza a stroncare energicamente i moti dei reduci per la terra, secondo quanto era stato loro promesso dopo Caporetto. Anche se a volte pagate con il sangue, si trattò di iniziative, mancanti com’erano di un vero progetto e di una seria direzione. A destra, il regime combatté la massoneria e i gruppi consortili che egemonizzavano la scena meridionale. Gli esiti di una siffatta politica furono incerti e confusi. Che io sappia, mancano studi esaustivi sull’argomento. Solo incasellando avvenimenti minori e slegati tra loro si può arrivare ad abbozzare un quadro meno incerto e sfumato. Certamente la consorteria fu battuta proprio sul terreno sociale -che era poi il suo modo di esprimersi politicamente- e cioè nell’organizzazione del clientelismo e nell’erogazione del "posto". Ciò consente di affermare che al Sud il fascismo si presentò e fu in effetti una forza moralizzatrice della vita pubblica. Probabilmente fu la stessa piccola borghesia, costretta ad accapigliarsi per uno stipendio, a trovare nell’organizzazione fascista del potere e della burocrazia una specie di rinnovamento, nel senso che quantomeno i meriti formali prevalsero e le raccomandazioni, certamente sopravvissute alla consorteria, ebbero un punto di riferimento stabile.
In sostanza si trasformò la posizione del pater. Prima era incerto, o perlomeno diffuso fra una pluralità di cosche in lotta fra loro, poi divenne solo, anzi unico come il partito. Ciò trasformò anche l’aspirante o cliente, in quanto non gli fu richiesta come contropartita un’azione sub-clientelare, ma soltanto un’adesione politica, che poi fu pigra e qualche volta la copertura di ben diversa posizione politica. Ma il fascio raramente negò la tessera a qualcuno, a meno che del suo spirito critico nei confronti del regime non facesse una millanteria.
Almeno in Calabria, il vertice visibile del potere non fu espresso soltanto dal gruppo dei maggiori redditieri, ma vi si inserì molta gente nuova, salita al rango borghese attraverso il diploma e la laurea. Tuttavia il fascismo consolidò (o non intaccò) il potere delle classi agrarie, le quali dietro le quinte conservarono la sostanza del potere, che non venendo più dall’elettore, non doveva più essere acquistato. Dopo di che tutto quello che quelle classi avevano perso sul terreno elettoralistico e clientelare, lo recuperarono sul terreno della tranquillità politica, mostrandosi il sistema fermo e stabile; e lo recuperarono anche sul terreno dei rapporti colonici, poiché la riruralizzazione fascista inchiodò i contadini in una gabbia dalla quale la fuga era difficile. I proprietari divennero tranquilli come mai lo erano stati negli ultimi due secoli, perché difesi da uno stato forte e attento in materia di controllo sociale: niente più briganti, niente camere del lavoro, niente fasci operai e mutue bracciantili o altre associazioni contestatrici. Pagarono logicamente un prezzo al sistema, a causa della più coerente e pesante imposizione fiscale e verso la fine del periodo soffrirono per una certa efficiente gestione degli uffici di collocamento.
Nei grossi centri, i galantuomini di maggior rango si configuravano come un gruppo privilegiato e protetto negli averi, ma generalmente separato dal regime e guardato a vista per il sospetto che all’interno vi covasse l’opposizione liberale, o che vi fosse propensione alla comunella con preti e socialisti.
E tuttavia anche i fascisti venivano dalla classe infame dei galantuomini. Erano galantuomini truccati, ma non redenti, in qualche modo resi inoffensivi, quantomeno in occasione delle tresche più plateali. Carlo Levi registra e presenta con irraggiungibile efficacia rappresentativa il caso dell’inglobamento nel regime degli antichi rancori tipici delle consorterie avverse, in un paesino dell’entroterra lucano. Nel retroterra jonico calabrese, il racconto dei più anziani si rifà a situazioni sostanzialmente simili. Nei paesi più poveri di borghesia professionista e di burocrazia addottorata e acculturata, il fascismo e l’antifascismo furono certamente usati anche nel senso tradizionale della consorteria, ma con molta più cautela che in passato.
Per quel che avvenne poi, dopo la caduta del fascismo, è di somma importanza ricordare che durante il ventennio si inaugurò, sotto la spinta della crescita secolare dei redditi, una mobilità sociale assolutamente ignota in precedenza. Anche se non di grandi proporzioni, il fatto nuovo incise sulla natura sociale dei ceti medio-superiori. Gli studi fino al diploma o alla laurea, in precedenza, erano stati aperti oltre che ai figli dei proprietari, anche ai figli dei massari e dei piccoli proprietari. Ma, nell’età dei galantuomini, le classi subalterne erano rimaste tagliate fuori persino dalla velleità di un simile sbocco. Solo qualche ragazzo più dotato arrivava al sacerdozio. Durante il ventennio, invece, non solo la popolazione scolastica crebbe, ma -ed è questo il dato significativo- riuscirono ad accedere agli studi anche giovani provenienti dalla minuta borghesia, da famiglie di operai e di artigiani, persino il figlio di qualche contadino meno affamato e rozzo. Gli esiti di siffatta mobilità ascendente si videro a partire dal 1943. Senza quei professorini e avvocaticchi di modestissima estrazione sociale, tutto il fiorire di sezioni socialiste e comuniste, che si ebbe nel Sud dopo la guerra, sarebbe stato impensabile.
La fine
Sulle trincee del Carso i galantuomini morirono a fianco dei contadini. Ciò forse avrebbe democratizzato la scena meridionale, ma subito dopo la guerra, il leninismo e il fascismo sospinsero il Sud completamente fuori scena.
L’antifascismo, che al Sud non fu un moto popolare, ma il chiacchiericcio serotino di una sorta di fratrie alquanto assortite di vecchi notabili e di meno vecchi peroratori del comunismo o del popolarismo cattolico, ridette fiato alla cosca. Nei paesi e nelle città -nelle spire coinvolgenti dell’antifascismo e nel conseguente clima di reciproca tolleranza (delle opposte e, in teoria, a volte inconciliabili etichette) si andarono formando dei gruppi notabiliari assolutamente inediti rispetto al trasformismo giolittiano e prefascista. Certamente in ogni luogo non mancarono gli idealisti (gli ingenui, si diceva) e quindi i contrasti e le avversioni anche vivaci, ma l’opposizione al fascismo finì per prevalere, così che i litigi vennero sempre superati.
Caduto il fascismo e perduta la seconda guerra mondiale, man mano che le truppe occupanti risalivano la parte meridionale della Penisola, gli attori che per primi si presentarono sul proscenio della restaurata democrazia furono coloro che si erano forgiati nei circoli riservati, nei salotti dell’antifascismo come in una loggia interclassista. Gli occupanti angloamericani, che mostrarono di essere ben informati sulle situazioni locali, si mossero, sin dall’estate 1943, con l’idea di restaurare il galantomismo. Affidarono il potere locale nelle mani dei cospiratori inoffensivi e fra loro solidali dei salotti antifascisti, e collocarono alla direzione dei comuni gente politicamente o personalmente affidabile. Più che la Chiesa, la loro eminenza grigia fu la grande massoneria. La quale, dove c’era, prese al suo servizio la mafia quale responsabile dell’ordine pubblico.
Durante i due anni circa, tra il ‘43 e le elezioni del ‘46, la gestione locale coinvolse però gli esponenti di tutte le bandiere politiche, poiché i Comitati di Liberazione Nazionale, che ebbero il riconoscimento di partner da parte degli angloamericani, provvidero a lottizzare le posizioni di potere fra i sei partiti che ne facevano parte (Liberali, Democrazia del Lavoro, Azionisti, Democristiani, Socialisti, Comunisti). Tuttavia, per il classico gioco delle tre carte, al potere andarono sempre dei conservatori o dei moderati, anche se a volte con il papillon rosso.
Lontani Mussolini, i tedeschi e la guerra, l’unico disturbatore della quieta unità antifascista fu il popolo, affamato di pane, di fabbriche, di terra e di uguaglianza. Negli anni dell’immediato dopoguerra, la parola democrazia ebbe una forte caratura popolare ed eversiva, quantomeno ebbe a significato che il popolo basso aveva raggiunto un sufficiente riconoscimento politico, e che, come corpo collettivo, poteva trattare da pari a pari con le classi proprietarie e signorili. Le classi subalterne vennero identificate nelle loro richieste sociali e di rappresentanza politica. In effetti, dopo il crollo degli apparati statali e la perdita del controllo che questi avevano sul territorio, il popolo poté credere che bastasse il numero per ribaltare l’assetto sociale. Esemplare in questo senso furono l’insurrezione e la Repubblica di Caulonia. L’attesa e la fiducia crebbero nei due anni seguenti, raggiungendo l’apice della parabola nel 1946. Successivamente, l’apparato dirigente locale del PCI o fu sostituito, o intese -e con esso le masse popolari- che il processo rivoluzionario si sarebbe dovuto dispiegare in un arco di tempo lungo, e che comunque non era quello il momento propizio per uno scontro frontale, come mostravano i fatti di Grecia.
L’atteggiamento popolare sospinse gli antifascisti che militavano nel partito comunista, e i molti improvvisati comunisti, tuffatisi nel PCI perché folgorati dall’idea socialista, o per opportunismo, o per qualche riposta ambizione, tennero con fermezza la loro posizione nell’ambito del nuovo quadro politico locale, contendendo all’avversario il dominio assoluto della società meridionale e contrattando i compromessi; ciò fino a quando, intorno al 1955, l’emigrazione falciò l’azione popolare e spense le speranze di un Sud che contasse in Italia.
Ma già prima il PCI aveva incanalato tale esigenza fondamentale della società meridionale verso l’aspetto minore dell’azione contadina per il possesso della terra. Per la verità la strategia del PCI non osò mai spingersi fino ad un’alternativa così secca. Certamente le lotte per la terra continuarono a tenere banco a sinistra, fino al 1951, ma ben inserite in un riformismo proprietario di corto respiro e di ambito rurale, mentre era chiaro che al centro dello scontro stava la città e il vero tema dello scontro era l’occupazione. Dove questo emerse spontaneamente, come nell’hinterland napoletano, nell’area tarantina, in quella barese, nel Crotonese, non trovò grandi solidarietà. Poi il momento rinnovatore ricadde e si appiattì in un partitismo locale senza respiro, poiché, al di là delle lotte proletarie, il Meridione era politicamente vuoto. Era (ed è) politicamente vuoto, perché era (ed è) politicamente dipendente. Perché era (ed è) soltanto la somma di orientamenti scollati e senza programmi, che si riducono a una cifra elettorale utile solo per i calcoli parlamentari su maggioranza e minoranza.
Nonostante la fase politica frontista, i comunisti non sempre ebbero l’appoggio degli esponenti socialisti. A quel tempo la tipologia del dirigente era quella di un essere con due anime e un corpo. Il corpo apparteneva di solito a un medico o a un avvocato, solo qualche volta a un artigiano acculturato nelle tematiche sociali (uno splendido ceto, politicamente e culturalmente ormai spento, l’ultima leva del quale è stata regalata senza contropartite al sistema padano). L’anima sensitiva si estraniava dal corpo: era per la democrazia e per il riconoscimento umano -dell’appartenenza, cioè, alla specie umana anche dei contadini, dei braccianti e delle frange sparse di proletariato senza mestiere delle aree urbane (in genere facchini a salario giornaliero, pescatori che dividevano con i capibarca il frutto della pesca, e consimili); un riconoscimento comiziale, concionatorio, demagogico che restava senza fiato quando si doveva passare ai fatti; l’anima razionale era quella colpevole di chi comprende la direzione del movimento storico e non può o non vuole opporsi, trattenuto com’è dal corpo piccolo borghese, benestante, addottorato. Le viscere piccolo borghesi soffocavano l’animo socialista, e quindi il socialista si barcamenava tra il cambiamento e la conservazione, tra le idee e la pratica, tra le classi padronali e il popolo, tra i moderati e i comunisti.
Per il fisico venir meno delle generazioni più intraprendenti del popolo, quel tentativo di democrazia meridionale si esaurì (ma non tanto inavvertitamente come parrebbe, se ci si limita ad un esame della cronaca giornalistica dell’epoca, già guidata da rigidi paraocchi romani e pertanto milanesi, o alla storiografia paludata che affronta con sussiego partitocratico il discorso su quell’epoca). Nel breve volgere di due o tre anni il moto era sconfitto, e già nel 1958, quando a sinistra cominciò a farsi luce il mancinismo, era completamente tramontato. Rimase tuttavia il nome di democrazia, il quale fu riempito posticciamente.
Con l’8 settembre, il mondo dei galantuomini si può dire definitivamente tramontato nelle braccia larghe dei Comitati di Liberazione Nazionale, tanto più ridicoli a causa della loro estrazione pantofolaia, della loro legittimazione offerta da un esercito straniero, spesso della modestia dei personaggi e per la loro mal riposta arroganza.
È tramontato e non si riproduce, perché in quel passaggio il mondo contadino taglia il filo spinato che lo separava dal mondo urbano, usando come forbice il mercato nero delle derrate agricole. I contadini escono dal neofeudalesimo sabaudo e fascista e s’insediano nel mercato, rivoluzionando il proprio modo di produrre, i propri consumi, il proprio rapporto con il resto del mondo. Quando arriverà l’Ape (la Vespa con cassonetto, della Piaggio) e l’asino sarà archiviato, se non ci fosse stata l’Italia padana a placcarlo, quel mondo nuovo sarebbe arrivato fino al suo giusto orizzonte.
Il secondo dopoguerra
Nel 1946, quando si ebbero le prime elezioni amministrative comunali, non tutti i raggruppamenti politici possedevano le stesse chance di successo. Comunisti, socialisti e democristiani, nel Sud, si erano già formati una base di massa; partivano quindi favoriti nel confronto con etichette oggi quasi tutte scomparse, ma a quel tempo ritenute importanti.
Nei comuni molto piccoli i proprietari pesavano ancora parecchio, ma sin dall’inizio furono costretti a mettere un distintivo all’occhiello. Generale e grande fu invece il peso delle parrocchie. Sin dal 1946 esse assunsero il carattere di una notevole forza clientelare e paternalistica, accanto a quello tradizionale di collettore del voto cattolico. Per cinque o sei legislature, la Chiesa ebbe la meglio su ogn’altro suasore politico. Se si prescinde dalle allocuzioni comiziali e dai bei battibecchi da marciapiede, anche gli altri partiti incorporavano una forte dose di vuoto politico, e solo l’eccitazione del momento portava a credere che le parole fossero sostanza. Freddamente esaminate le loro posizioni, esse si presentarono come entità fortemente sfumate e in certa misura intercambiabili.
L’inglese Tarrow ha scritto un libro molto interessante sull’arcobaleno dei colori politici che presenta il Meridione in sede di potere locale7. Il comune A è democristiano, il comune B, contiguo, è comunista; il paese C, che sta dall’altro lato, è a prevalenza socialista. Il tutto si mostra senza senso e senza alcuna logica politica. Zone economicamente omogenee, per cui un diverso orientamento comunale non sarebbe giustificato, contengono invece coloriture partitiche diverse, spesso una per municipio. La spiegazione è che ad A si è formato un gruppo di potere democristiano intorno a due medici e due avvocati democristiani; che a B un professore e un avvocato hanno fatto da volano a un’espansione comunista; che a C tre avvocati e un professore socialisti si sono mostrati i più idonei a guidare il paese.
La spiegazione storica risiede nel fatto che nel Meridione, nonostante il fervore di quegli anni, la politica è impolitica; che gli interessi di fondo restano nascosti e che l’azione politica dei partiti nazionali non li scalfisce neppure. Storicamente, infatti, dopo cento e più anni di dominazione padana, gli interessi del Sud sono complessivi, nazionali (nel senso di propri, di regionali) e travalicano le classi. Il Sud, inteso come paese, necessita di uno sviluppo che nessuno dei partiti nazionali intende seriamente propugnare; il suo interesse generale è quello di contrapposi al Settentrione. D’altra parte nessuno dei partiti nazionali fa emergere la contrapposizione interna al Sud (propriamente sua e non italiana) tra conservazione e rivoluzione.
Solo nell’immediato dopoguerra e in luoghi delimitati, si sviluppò, sotto la guida del partito comunista, un’azione consistente rivolta alla conquista delle terre incolte o mal coltivate e contro il latifondo. È solo in queste zone che si ebbe un reale scontro politico. Altrove, sicuramente in centinaia di comuni grandi e medi, con tradizioni industriali, le forze del lavoro si compattarono sulla borghesia attiva -e dov’erano più forti, come al mio paese, si allearono con essa- nella mal riposta speranza di una politica del lavoro e dello sviluppo. Ma più in generale, le situazioni locali furono determinate da figure paesane, sia nella veste dell’uomo dotato di "amicizie in alto loco", quindi capace di trovare un "posto" agli amici, sia nella veste del leader carismatico, sia ancora sotto la forma di gruppo dirigente affidabile e meglio preparato del gruppo o dei gruppi avversari, sia infine le tre cose interconnesse fra loro.
A partire dalle prime elezioni, i gruppi vincenti tesero a riprodurre la consorteria. Dal lato opposto si formarono gruppi consortili di diversa etichetta, ma senza un reale colore politico, che si candidarono per il ricambio. In realtà, essendo il Meridione bloccato (o per usare un azzeccato termine sportivo, placcato) al suo destino di periferia non decidente, la lotta che si sviluppò al suo interno fu soltanto elettoral-partitica e quasi mai autenticamente politica. Favorito dalla preferenza al voto di lista, l’elettoralismo sostituì il notabilato e se le consorterie non si presentarono più come appartenenti all’onorevole Caio a Marefreddo e all’onorevole Tizio a Solecaldo, ma apparvero come socialiste, comuniste, democristiane, ciascuna alimentata dall’animosità per la propria fazione, ciò fu mera apparenza. Dietro la facciata non c’era il partito ma, come vedremo, la cosca.
Gradatamente poi, nel corso di quegli anni, i proprietari persero peso economico e politico (salvo riacquistarlo quindici anni dopo, intorno al ‘68/’70, come venditori di suoli edificatori). Con il declino economico della rendita, i proprietari persero anche la connotazione di classe a sé stante e a volte fortemente staccata nel contesto sociale, confluendo nell’enorme calderone dei ceti medi alimentati da uno stipendio o da entrate professionali. A questo riguardo è una vera e propria falsificazione politica quella che collega il mutamento delle relazioni in agricoltura alle nuove leggi, e principalmente a quella di Riforma Agraria, che colpì i latifondisti. Nuove relazioni di lavoro, magari introdotte dall’alto, diventano operative solo se matura un nuovo equilibrio (regionale) tra offerta e domanda di lavoro, altrimenti restano carta stampata. In realtà i salari agricoli lievitarono soltanto perché le campagne si spopolarono in seguito alla domanda europea e padana. Ciò mise in ginocchio i proprietari, le cui rendite, si dice, derivino dalla terra, ma che in effetti derivavano soltanto dalla fame e dal superlavoro del contadino.
Al Sud, il partito di massa, salvo i luoghi dove la lotta per la terra ebbe un carattere effettivo, fu ed è di massa solo per gli elettori, che vengono attratti per lo più dalle relazioni extrapolitiche descritte da Tarrow, mentre fu di élite per i gruppi dirigenti. Rifacendomi a quanto sostenuto sopra, bisogna dire che la stessa situazione oggettiva spingeva verso la riformazione della consorteria. Infatti i partiti di massa si scontravano sul terreno di interessi ristretti, che se non erano familiari, non volavano tuttavia più alto del natìo borgo selvaggio, relegando la cosiddetta "questione meridionale" in frasi enfatiche ed insensate, collocate in fondo alle loro dichiarazioni programmatiche.
I pochi tentativi che i gruppi dirigenti locali fecero per inserire i problemi dei rispettivi luoghi in un contesto più ampio caddero nel vuoto e nella sordità non appena arrivati a livello di dirigenze provinciali e nazionali. È quindi alquanto naturale e logico che la vita politica ripiegasse su se stessa e che le vocazioni al comparaggio consortile avessero il sopravvento sulla vera politica. Il soffocamento delle istanze locali appare più marcato nel PCI proprio perché questo partito contestava il sistema e si era profuso con generosità nella lotta contadina. Ma alla prova dei fatti, il PCI si è dimostrato il più nordista dei tre grandi partiti di massa. Ciò merita una spiegazione, sia pure rapida.
In Italia, il PCI leninista si è comportato nei fatti -sin dal 1944- come un qualunque partito socialdemocratico europeo. Come tale non ha rifiutato le rivendicazioni economiche provenienti dal basso, tranne che in Meridione. Qui, tra il 1945 e il 1985, la grande rivendicazione fu il lavoro, ma su tale tema il PCI e la CGIL disquisirono parecchio senza mai scendere a un serio scontro con il sistema. Si pensi alla rassegnazione preventiva -alla supinità- con cui andarono incontro alla perdita delle roccaforti rosse nel Sud; alla resa, senza l’onore delle armi, di Castellammare, di Torre Annunziata, di Barletta, di Taranto, di Crotone, per citare soltanto i luoghi di cui chi scrive ha memoria. Certamente il PCI non fu in malafede. La spiegazione è un’altra: nessun partito può servire due altari, quello dello sviluppo e quello del sottosviluppo; non può cantare contemporaneamente il Te Deum laudamus e il Dies Irae.
La cosca politico-intrallazzistica
La presenza di cause materiali ed esterne non significa che la rinascita della consorteria, sotto forma di cosca elettoral-trafficona, non sia stata un male oggettivo per la vita politica meridionale. La sua evoluzione in superpartito corrisponde all’aggravarsi della malattia contratta nel 1860. Il gruppo politico locale, che andò identificandosi come gruppo di testa nelle istanze di partito, si trasformò in cosca proprio per la sua sterilità a fare vera politica. In pratica i più onesti, i più capaci si autoemarginano o vengono emarginati, lasciando ai meno onesti e capaci la guida del partito. Cosca vuol significare un nucleo alquanto ristretto di persone legate fra loro dal patto esplicito o tacito di sostenersi reciprocamente all’interno del partito e di trafficare all’esterno illecitamente assieme. In ordine di tempo il primo fatto illecito o ai limiti del lecito -comunque non encomiabile- risiede nel blocco delle preferenze, nel fare in modo che la cosca esca promossa elettoralmente, sia che si tratti di partito di governo sia che si tratti di partito d’opposizione. La lotta per la poltrona, che è dovunque uno degli aspetti deteriori della democrazia elettorale, qui al Sud è qualcosa di più e di peggio. Si dice da noi "u cumandari esti megghiu du futtiri" (comandare è meglio che fare all’amore).
Nell’ambito della borghesia laureata, qui, le scelte sono prefissate: coloro che hanno capacità e prospettive di successo restano nella città dove hanno preso la laurea, gli altri tornano a casa, a marcire. Una volta qui, la poltrona invade i loro sogni e carezza le loro natiche. Sanno di essere degli sconfitti, che rimarranno in serie B, che fino alla fine saranno dei subalterni, ma vogliono quantomeno essere i primi degli ultimi, avere un riconoscimento sociale.
La cosca mira al successo elettorale, ma non avendo progetti politici ripiega sulla formazione di una larga clientela impolitica, la quale si aspetta aiuti concreti, come posti e carriere, e ancor più trasgressioni amministrative in funzione persino dei più piccoli interessi, come costruire dove non è edificabile, bloccare i contatori dell’acqua e della luce (in attesa dell’apertura dei contatori del metanodotto algerino), irrigare gli orti con l’acqua che gli abitanti del centro centellinano e via dicendo, per una casistica che solo un compilatore del Digesto potrebbe elencare.
Da tempo, nel Sud, essere un militante di base significa soltanto tirare la volata elettorale alla cosca, persino senza saperlo. In tale situazione viene meno la voglia di partecipare, non solo, ma decade anche la coscienza individuale e collettiva, che degrada nella truffaldineria, nell’imbroglio, nell’intrallazzo. Si tratta comunque di cose ben note, sulle quali sarebbe superfluo insistere. Vorrei annotare soltanto che i missini da una parte e i comunisti dall’altra seguono percorsi diversi nei casi frequenti in cui non sono maggioranza locale. I missini hanno affidato il loro successo o all’ideologia immaginata come fascista, ma solo patriottarda, moraleggiante, fondata sulla identificazione tra democrazia e corruzione, ovvero al leaderismo di un qualche loro esponente migliore. I comunisti, sempre che non siano partito di maggioranza, hanno un’area di consenso ideologico, ma la disperdono amministrandola secondo le ambizioni degli esponenti, i quali litigano preventivamente su chi dovrà essere eletto; sempre più raramente spingendo alla ribalta i più meritevoli, cosa a cui preferiscono una selezione in base alla fedele ripetizione della linea della direzione nazionale.
I danari dell’intrallazzo politico
A partire dal primo intervento straordinario si aprì, per le popolazioni meridionali, una strana condizione, di cui allora non si riusciva ad intravedere la linea di fuga.
Oltre ai profondi sussulti che si avevano nel mondo contadino, sui quali si è scritto parecchio8, il Sud vide il precipitoso declino della rendita e anche il proliferare di servizi, come la scuola, fino a quel tempo molto ristretta, e quindi il moltiplicarsi degli alunni, dei maestri e dei professori; vide l’avvio all’impiego delle donne della piccola e media borghesia; vide l’arrivo di una proluvie di merci nuove e la maggiore accessibilità dei prezzi industriali. Fu un momento di estrema contraddittorietà, in quanto tutto quel che era vecchio e autoctono moriva, mentre chi si metteva al servizio del capitale nordista ci ricavava una fetta di moderno plusvalore. L’economia meridionale peggiorava, ma si ebbe l’impressione che migliorasse, tanto è vero che fu larga la partecipazione di coloro che si buttarono a capofitto in nuove iniziative imprenditoriali, con il risultato (certo gradito a Milano) di inaugurare un "cimitero d’industrie".
Comunque crebbe l’occupazione extragricola e crebbe il livello dei salari e degli stipendi; le condizioni più generali di esistenza cambiarono positivamente. Non so se per questo o per un certo fervore di vita nuova legato alla società politica, certo è che il vecchio contesto sociale si spezzò. La stratificazione rigida del passato, con il barone ancora al centro e gli altri redditieri intorno, assieme al medico di successo, e tutto il resto sotto, evaporò senza lasciare né ricordi né profumi. Il nuovo assetto spostò l’asse delle entrate dalla terra all’impiego, anche per gli stessi proprietari. Per i braccianti invece il nuovo asse divenne il lavoro extragricolo dell’edilizia9. I rapporti sociali si ammorbidirono. Il voto, i partiti, lo stesso clientelismo, il bisogno che i pesci grossi della politica paesana avevano dei piccoli pesci elettorali, tutta una serie di fattori che non saprei elencare e definire contribuirono a creare un clima di democraticità, o apparente democraticità sociale. La rigidità delle relazioni si sciolse e perfino gli aristocratici proprietari uscirono dai palazzi e accettarono relazioni con altri gruppi sociali, mostrando peraltro una correttezza nuova e quasi rispettosa verso gli appartenenti ai gruppi censitari bassi.
In questo clima nuovo e dai profili incerti, la grossa novità per tutta al società meridionale fu la nuova figura dello stato (Welfare) come erogatore oltre che degli impieghi anche di provvidenze, sussidi, agevolazioni, contributi e più in generale la notevole espansione dello stato imprenditore, sotto lo pseudonimo di Cassa per il Mezzogiorno (cosa che tra parentesi può dare l’idea di quanto grandi fossero stati i benefici tratti per oltre un secolo e quelli attualmente ricavati dal Centrosettentrione, per effetto di una spesa pubblica migliaia di volte superiore e del protezionismo doganale).
Il solletico che sempre e dovunque aveva dato la sedia in curia, la poltrona imbottita di sindaco, la medaglietta di deputato, ora comincia a essere accompagnato da un diverso tipo di solletico, pur esso antico, quello delle dracme, vulgo lire, da intascare sia come provvidenza o sussidio o contributo, sia come bustarella, tangente, partecipazione fraudolenta. Oggi si parla tanto di tangenti mafiose, ma in verità la strada del passamano era stata inaugurata da Cavour e pare che lo stesso Vittorio Emanuele II, detto pure padre della patria, non fosse insensibile all’odore delle monete, e persino delle monetine, proprio quelle di rame.
Sul finire degli Anni Cinquanta si arriva a un primo allargamento della cosca, nel senso che essa comincia a incorporare ingegneri del genio civile, funzionari della Cassa e della riforma fondiaria, grandi studi romani, progettisti di opere pubbliche e via dicendo. All’odore delle dracme, il gusto per la politica si diffonde. L’ingegnere che ambisce d’ottenere una progettazione, il medico che aspira allo stipendio sicuro della Mutua, l’avvocato che gradisce di tanto in tanto una buona consulenza, prendono la tessera, e con loro, appaltatori e commercianti. Chi ha resistenze circa la tessera, promette un certo numero di voti. Per farla breve, nasce un clientelismo corrotto e la deviazione politica con fini fraudolenti fa agio sulle virtù pubbliche.
La dipendenza politica
Prima novità: l’emigrazione. Seconda novità: per la prima volta dopo un secolo d’unità la spesa pubblica, sotto il nome sonante di Cassa per il Mezzogiorno. Terza novità: la pensione ai contadini e poi la pensione sociale. Sembrerà poco a chi vive di molto, ma per il povero cafone del Sud è stata una grande conquista. In assenza di meglio, l’assistenzialismo è già qualcosa, anche se i contadini e gli altri vecchi lavoratori non sono ripagati nella stessa misura degli operai per il contributo da essi dato, lungo una vita di fatiche e due guerre all’economia nazionale. Non c’è che da ringraziare la DC per questa inversione di rotta dell’italico colonialismo, inversione certamente ispirata a logiche keynesiane e tuttavia proficua a un popolo di lavoratori, che ha dato al paese molto più di quanto gli sarà mai restituito. Ovviamente la DC non va più oltre. Il suo meridionalismo è tutto qui. Contro i diktat della Confindustria, il cui pensiero è chiaramente enunciato in un famoso testo dell’economista Vera Lutz (che come i giocatori della Juventus venne pagata con i nostri soldi), sarebbe pericoloso andare, persino per coloro che attraversano spesso il Tevere.
Ma la pensione serve a risolvere il problema del pane oggi, ma non quello del pane di domani, che forse è più importante persino per gli stessi vecchietti. Inoltre, erogando i diritti come favori, la DC ha contribuito notevolmente a rendere democratica la corruzione politica, che alla fin fine era un fatto delle élite -in grande stile a Milano, sotto forma di sussistenze familiari al Sud.
All’avvio del Centrosinistra, il PSI ebbe una proposta onesta: la programmazione nazionale e il riequilibrio territoriale; onesta ma irrealistica, perché sottovalutava il gioco degli interessi settentrionali e il blocco d’interessi tra finanza, industria e sindacato, i quali non gradivano che l’occupazione e i profitti settentrionali subissero insidie. Posizione che l’ipocrisia degli economisti dichiarava miope, salvo a consigliarla nel segreto delle ovattate direzioni padronali. I monopoli di fatto sono la vera historia dell’industria padana. Di ciò i socialisti non seppero tener conto e furono sconfitti già prima di cominciare. Una volta sconfitti, e purtuttavia aggregati al governo, si sono messi a fare concorrenza alla DC sul terreno clientelare. Quest’ultima parte del discorso riguarda anche il PSDI e i repubblicani, a proposito dei quali non bisogna sottacere l’incredibile abilità di apparire il "partito morale" a Milano e di trafficare con la mafia, oggi più e meglio della DC, in Sicilia e Calabria.
Il PCI non può scegliere: il suo elettorato più consistente è il lavoratore garantito. Servendo lo sviluppo in concreto e tuonando sull’immoralismo degli avversari, riesce ad avere un certo seguito al Sud. Nelle amministrazioni locali, però, non potendo e volendo concludere niente di positivo, si affloscia alla prima prova di governo e gli elettori lo spazzano via, salvo che non abbia già imboccato la strada del superpartito.
Il superpartito
Finché funzionò la triade emigrazione, lavori pubblici, assistenza, la cosca si sorresse da sé. Sindaci e assessori ottenevano da Roma lavori pubblici -utili e meno utili. Coi lavori pubblici ingrassavano ingegneri, progettisti, appaltatori, subappaltatori, ecc. Questi, a loro volta, portavano preferenze e pagavano altre mazzette. La mafia, che entrò nel giro degli appalti, fece il resto. Ogni parvenza di legalità se ne andò a ramengo. Segretari di prefettura, membri delle Giunte provinciali amministrative, impiegati del Genio Civile e del Demanio pubblico e chi ne ha più ne metta, furono risucchiati nella cosca.
Ora, solo chi ha anche un quadro approssimativo di come funziona "Cosa nostra" o la mafia in Sicilia, può agevolmente capire che la lotta tra le cosche mafiose non è pagante. Serve solo a farsi del male e a distruggersi reciprocamente. Allo stesso modo in politica. La cosca politica imparò a non sputtanare la cosca avversa perché, se e quando fosse toccato a lei amministrare, ci sarebbe stata una ritorsione. Il sistema si configurò nel tempo. Infatti la cosca vincente ebbe la convenienza di cedere qualcosa alla cosca perdente, oltre al resto, compromettendola, in modo che lo sporco restasse dentro al sistema di potere. A questo punto le cosche cominciarono a studiare accordi preventivi non sulla spartizione, ma sulla confezione della torta. Tanto va all’Impresa per il lavoro, tanto va alle Imprese del subappalto, tanto all’Onorevole Caio, tanto al Partito A, tanto al Partito B, il resto al Sindaco e al Presidente della Corte. Tutti finanziati, tutti compromessi e tutti felici. Così che l’intero operare amministrativo finì con l’essere sotterraneamente diretto e deviato verso logiche intrallazziste.
È stato questo il primo filo, quello intuibile dall’esterno, del superpartito. Un altro riguarda precipuamente i posti e le carriere. Ai tempi della consorteria, un gruppo escludeva l’altro, e così in appresso, al tempo della cosca semplice. Oggi, con il trionfo del superpartito, non è più così. L’assessore di cosca socialista deve dare il posto al figlio dell’appaltatore di cosca democristiana. Il bidello di cosca comunista deve essere promosso applicato di segreteria dal provveditore democristiano. Al ragioniere della USL di cosca democristiana il CO.RE.CO. (Comitato Regionale di Controllo, ndr) deve riconoscere il grado di dirigente e gli arretrati. E così via. I deve che ho messo in neretto non sono enfatici, casuali, semplici impressioni; sono la nuova legge non scritta, ma osservata rigorosamente all’interno del superpartito. Tuttavia il superpartito non va inteso come la cosca centrale, come la rapsodia delle cosche che non si sono sciolte e tuttora vivono e prosperano, ma qualcosa di più sottile e al tempo stesso di più corposo.
Il primo bozzolo del superpartito è stata ed è la Massoneria, o quantomeno un certo modo degradato di vivere la fede massonica. Qui il discorso potrebbe farsi molto ampio, perché in Meridione è chiara la tendenza a fare della massoneria, come pure di club visibili, come il Rotary, i Lyons, delle mere associazioni di interessi. Comunque l’appartenenza in Massoneria non ha, al Sud, lo stesso significato che si legge nei libri. Certo ci saranno anche qui dei massoni veri, ma la maggior parte dei massoni meridionali sono squalificati e degradati. In Meridione, la Loggia ha svolto e svolge prevalentemente la funzione di mettere in contatto intrallazzisti delle varie cosche. Anzi credo di non sbagliare affermando che il primo contatto tra coscanti di gruppo diverso si sia realizzato nelle Logge. I Lyons e i Rotary, nonostante la loro apparenza decorativa e classista, credo abbiano avuto ed abbiano, fra le loro nobili istanze, anche una funzione del genere.
Volendo tentare di definire il superpartito, si potrebbe dire che è un’entità nebulosa, un riferimento tra l’amicale e l’intrallazzistico, un’associazione informale che si serve della cosa pubblica per far lucrare agli adepti profitti sostanzialmente e spesso anche formalmente illeciti, ma che ci siamo assuefatti a considerare un aspetto positivo dell’agire sociale personale, anche se poi, qualche volta, ce ne lamentiamo come di un fatto pubblico non limpido. Ma per quanto nebuloso nella forma, il superpartito è tuttavia una realtà operativa che incombe sulla vita materiale del cittadino meridionale. Credo che nella ricostruzione delle zone irpine e lucane colpite dal terremoto, a proposito delle quali tanto si parla di camorra, si trovi -a voler indagare- la chiave di lettura della mostruosità crescente del superpartito nel Meridione. È stupido dire "la camorra ci ha messo le mani". Le mani ce le hanno messe e ce le stanno mettendo tutti: dai sindaci agli assessori comunali, dai progettisti agli appaltatori, da persone colpite dal terremoto ai dirigenti superiori dei ministeri, dai parroci agli allevatori di maiali, dai vigili del fuoco ai dipendenti locali dell’Enel, dai generosi soccorritori ai produttori di ferro e di cemento, dai democristiani ai socialisti, ai comunisti, ai repubblicani, ai socialdemocratici, dalla stampa napoletana ai corrispondenti e inviati dei grandi quotidiani milanesi. E si farebbe un errore a scambiare la cosa per un fenomeno di generale corruzione. Questa c’è senz’altro, e si vede, ma i luoghi di decisione e di controllo operano secondo la regola dell’illegalità sostanziale coperta in genere dalla legalità formale; gli scontri politici -che pur ci sono- riguardano tutto, meno che la bestia con la quale nessuno intende misurarsi e che è comunque ritenuta così potente e vendicativa da scoraggiare anche i più onesti e coraggiosi ad aprire il capitolo.
Altro esempio clamoroso di gioco politico dentro le regole del superpartito si è visto in Calabria dopo le ultime elezioni amministrative. Per comporre il mosaico dell’assegnazione di presidenze, assessorati, poltrone di sindaco, presidenze provinciali, ci son voluti quasi sei mesi. In tali casi, i responsabili usano la parola organigramma, che sa tanto di bilancetta dell’orefice. I giornali hanno detto solo quello che i superpartitici desideravano; la gente della strada ha chiacchierato, ma in fondo se n’è fregata (nulla cambia, ha detto). Ma a guardar bene non è una novità della vita politica, né tantomeno la sua transustanziazione in affare personale, in poltrona; anche questo, ma è stato soprattutto gioco sottile e feroce, o intercosca nascosto dalle cosche, tutte ossequianti alle regole del superpartito. E si badi ancora, il gioco non ha riguardato le poltrone di questo o di quello, ma la ridistribuzione dei pesi all’interno del superpartito, fatto non per governare ma per intrallazzare. Dietro la poltrona di Tizio c’erano infatti tutti gli ammanigliamenti sottostanti e i collegamenti laterali. Non è stata una disputa di squallidi politicanti, ma il gioco bizantino di abilissimi e consumatissimi diplomatici, i quali quando pronunziano la parola sindaco non si riferiscono soltanto a chi dirige un comune, ma a chi dovrà, e a come dovranno lucrarsi gli utili sommersi di quel comune, e a come andranno rifatte le carriere e assegnati i nuovi posti.
In Meridione la politica è un agone senza opposizioni reali e veritiere. La facciata nasconde la farsa. Dietro la facciata c’è l’arrembaggio alla cosa pubblica, dal quale maggioranze e opposizioni traggono lucro. Fino a dieci anni fa, ciò dipendeva dal vuoto esistente nei partiti nazionali, per quanto concerneva le relazioni in Meridione; oggi, persistendo il vuoto, il superpartito ha sciolto i partiti e governa al loro posto. Siamo insomma al partito unico.
I governi cosiddetti democratici hanno salvato la piccola e media borghesia meridionale e l’hanno allargata, con l’evidente intento di realizzare un sostegno alla loro politica nordista e anche per dare un sostituto alla classe dei galantuomini. Nella misura in cui a Torino, a Genova, a Trieste, a Milano nascevano fabbriche, che sarebbe stato giusto e opportuno ubicare a Napoli o a Palermo, nel Sud sorgevano scuole e ospedali, non perché si insegnasse qualcosa o per curare gli ammalati, ma per produrre infermieri, bidelli, applicati di segreteria, professori, comitati di gestione, medici ospedalieri, e via dicendo. Adesso la cuccagna è finita. Niente operai, niente infermieri. I soldi servono ad Agnelli per ristrutturare e competere -almeno così dice lui, e tutti gli danno corda.
In ogni caso è chiaro ormai a tutti che la belle époque neocapitalistica e weberiana è finita. Il mangime da ingrasso comincia a scarseggiare. Gli stipendi comprano appena lo stesso, o qualcosa di meno, poiché il loro livello in termini reali non cresce più di mese in mese. Di ciò la gente si rende conto anche se non legge i giornali. Ha pure capito che la strada imboccata dal sistema non è destinata a cambiare nella prospettiva di breve e medio termine. Logicamente chi è sferzato si contorce, e così i componenti della piccola e media borghesia, le quali riempiono di sé il quadro sociale meridionale. Cercano di salvarsi, chi ad ordine sparso e per proprio conto, chi stringendosi di più alla cosca. Ma salvarsi è cosa tutt’altro che facile. I fessi si son messi a coltivare un orticello, in modo da crearsi una sussistenza; quelli ammanigliati armeggiano con il TAR ed il CO.RE.CO. per ottenere riconoscimenti di carriera, integrazioni di stipendio, promozioni; coloro che comandano la baracca hanno rotto le fila e vanno all’arrembaggio di gettoni di presenza, straordinari, trasferte che non fanno, forniture agli enti pubblici attraverso ditte intestate alla suocera. Magistrati ordinari e amministrativi, dirigenti e autorità amministrative danno una mano agli amici e la negano agli altri. Già questa sensazione di frustrazione spacca i pubblici dipendenti in tutelati ed esposti. Ma una sensazione di insicurezza è ancora più diffusa tra le popolazioni non stipendiate, perché è venuta meno la fiducia collettiva, la speranza diffusa che lo stato Provvidenza un giorno o l’altro avrebbe finito con il baciare anche loro.
Siccome, i posti nuovi diventano sempre più scarsi, si è scatenata la gara a chi fa prima a sistemare i figli. In tali gare, i meriti, i titoli sono spesso inventati di sana pianta. A favore degli amici, e per gli amici gli esami di concorso sono solo un gioco da prestigiatore. Intorno all’esame per un posto di maestra elementare non si muovono più le tradizionali raccomandazioni, ma si mette un moto tutta una macchina di sorteggi sballati, di malattie inesistenti, di sostenitori organizzati allo stesso modo dei picchiatori nei campi sportivi. Il presidente di una di queste commissioni un giorno mi disse: "Vedi, me ne sto al caffè a leggere il giornale perché, altrimenti, dovrei denunziare tutti, perfino i bidelli. E se li denunzio, mi gioco sicuramente la tranquillità familiare e forse anche la pelle". Intorno a un progetto, si muove la direzione centrale del partito e un tal numero di amici che, se ognuno di loro portasse un blocco di pietra, si costituirebbe una piramide. Per il figliolo, per il cugino, per il compariello, il cognato, il nipote di uno che conta, si sviluppa un coinvolgimento diffuso, non a catena ma a raggiera, a passo di plotone, che scavalca i partiti, le burocrazie, le leggi, la correttezza, la civiltà, l’urbanità. L’intero sodalizio procede accerchiando, raggirando, stravolgendo, pigiando, nel disprezzo più completo degli altri cittadini (cosa non nuova) e degli altri esseri umani (cosa nuova).
Quando, poi, a far parte della parrocchia sono tutti i concorrenti, allora comincia un gioco a scacchi di tipo scientifico. Nessuno deve essere scontentato, cosicché, se muovo la Torre in A5, contemporaneamente l’Alfiere va in H4, il Cavallo in C3, la Regina in F6, il Re in D8, tre pedoni vengono avanti e quattro tornano indietro. Caso eclatante, le recenti nomine, subnomine, pseudonomine, criptonomine in un istituto bancario meridionale (in effetti lombardo-piemontese). Per un presidente promosso ad alto incarico, tutta la scacchiera venne sconvolta: i Cavalli diventarono Torri, gli Alfieri Regine, i Re persero la corona e due-tre pezzi di scarto furono mangiati senza complimenti. Il tutto con la benedizione del Ministro Goria, di De Mita, Craxi, Longo, Spadolini e dei loro propretori locali, e con gaudio dell’onorevole Puijia e mortificazione, s’intende parziale, dell’onorevole Mancini. Personaggi senza nome e senza volto, come Carmelino Puijia, ma che si tirano dietro un gregge di due, tremila amici di tutti i colori, possono far ingoiare rospi grossi come uno scoglio anche a gente che da trent’anni è un mezzo padreterno.
Ho affermato che i partiti sono politicamente disciolti; che l’unica funzione che è loro rimasta è quella di supporto nominale della cosca. Infatti, a questo punto, anche la vecchia conta delle percentuali politiche non ha più valore. L’unica cosa che adesso conta è che il circuito sia ben oleato. Per fare un esempio: se il posto di presidente della Regione e quello di usciere della pretura spettano, secondo questa entità, a Caio e Sempronio, i due avranno il loro posto, siano essi democristiani, socialisti, comunisti e via dicendo. Ma se il posto di usciere fallisce, anche quello di presidente va ridiscusso.
Non avendo neanche i numeri un peso specifico, ma contando solo le persone come capifila, o come quinti, o novantesimi della fila, anche la cosca appare superata. Al suo posto è comparso un sodalizio senza colore che imbroglia le leggi, i pesi e le misure. Qualcuno ha chiamato tale entità "mafia bianca". E di mafia si tratta, ben più pericolosa della mafia tradizionale. La gente che sta dentro siffatta mostruosa associazione ha una forte coscienza mafiosa e una debole, o forse fievole, o forse nessuna consapevolezza di operare sopra le leggi e a dispetto di esse. La cosa diventa del tutto d’una eleganza impareggiabile quando intrallazzo toscopadano e mafia bianca del Sud s’intrecciano10.
La mafia bianca è un organismo di natura borghese e di carattere superpartitico, rivolto: 1) a sostenere persone determinate affinché non siano coinvolte nel generale cedimento economico dei ceti impiegatizi; 2) a difendere o migliorare la posizione economica propria e degli amici; 3) ad assicurare ai figli una sistemazione, e magari una buona sistemazione; 4) a lucrare utili consistenti ritagliati dalla spesa pubblica. Tutto ciò non solo usando come sempre il bizantinismo amministrativo, ma procedendo oltre, e cioè vincolando i controllori a non esercitare il dovuto controllo. Non è lassismo sociale, né uno scambio di favori, è una norma munita di sanzioni come sopra elencate. Chiunque viva ed operi nel Meridione, stia dentro o fuori del gruppo, deve rispettare il losco codice della mafia bianca, altrimenti paga sulla sua persona, con le proprie sostanze, sulle persone dei congiunti, tale e quale le regole della mafia tradizionale.
La presenza della mafia bianca spacca il mondo meridionale con un fendente in due sezioni precise ed opposte: gli inclusi e gli esclusi. Gli uni hanno superdiritti, superdifese, gli altri debbono pagare per godere dei propri diritti e quando necessita sono lasciati alla deriva. Dove questa spaccatura porti è un’incognita. Intanto qualcosa di nuovo già si profila all’orizzonte: la lotta tra mafia tradizionale e mafia bianca, la quale, facendo parte del sistema più che la mafia tradizionale, oggi riceve l’appoggio delle forze dominanti. Sembrerà questa un’assurdità, eppure è semplice: la torta è più piccola di prima e la borghesia non vuole perdere la sua quota. Esplora strade nuove per salvarsi e fra queste c’è anche: "Muoia pure la mafia. I voti ce li troveremo da soli".
La società meridionale è tuttora "una grande disgregazione sociale" non solo per chi ha nelle orecchie il paradigma tracciato da Gramsci e sotto gli occhi una tipologia sociale che lo rispetta e lo ripete, ma per chiunque, in quanto, ad ogni soffio di vento, il gallo in cima al comignolo cambia direzione. Il fatto che oggi il pane non manchi più, e che ci sia anche il companatico, non significa progresso. Il Meridione è decaduto e continua a decadere come realtà produttiva; è bloccato nella sua condizione di improduttività gestita dal sistema metropolitano. Finché questa gestione esterna, fino a quando questa abdicazione alla sovranità che ogni popolo dovrebbe avere sulle sue naturali risorse continuerà, persisterà anche il decadimento delle coscienze, l’arrembaggio, il sottogoverno, la tramutazione dei diritti in favori, il misconoscimento dei meriti e l’esaltazione dei demeriti. Solo in tale habitat può fiorire una cosa mostruosa come la mafia bianca.
1 La nozione che qui si dà è diversa da quella crociana. Storia del Regno di Napoli, Laterza, 1924. Croce parla del signore, titolare ancora di un feudo in provincia, il quale, al tempo del Viceregno spagnolo, di regola vive a Napoli, oziando. Qui invece ci riferiamo a un’epoca diversa, il secolo XVIII e i due seguenti, e a persone altrettanto oziose, e tuttavia i veri detentori di ricchezza nella società regnicola.
2 Nicola Zitara, L’unità d’Italia: nascita di una colonia, oggi Vª edizione, Siderno, 1996.
3 Non si fa alcuna lacerazione alla patria storiografia se qui si ricorda che l’autoemarginazione dalla vita politica è un fenomeno di grave peso nella vita del Sud italiano. Meriterebbe invece un attento esame la vasta adesione patriottica a guerra già scoppiata, a partire dal 1915, e ancor di più la vasta attenzione che il neofascismo ha esercitato per cinquant’anni nel Sud.
4 Gli storici di tutte le correnti culturali e politiche bollano la borghesia meridionale post-unitaria di limitatezza di idee, di pochezza tecnica, di mancanza di iniziativa. La causa preferita della cosiddetta "questione meridionale" è l’inettitudine e la povertà culturale degli "agrari". Ma quanto è vera l’affermazione? In verità nessuno li ha messi alla prova, in quanto le consistenti ricchezze meridionali furono risucchiate dallo Stato nel corso dei primi quindici anni di vita unitaria.
Con quali mezzi dunque l’iniziativa privata meridionale avrebbe avviato quel sistema industriale che il Triangolo Genova-Milano-Torino creò solo con l’ausilio di consistenti aiuti pubblici diretti e indiretti, e dopo essersi impadronito politicamente dello Stato stesso e dopo aver corrotto la classe politica? Poi, una volta stabilito il vantaggio, un successivo inserimento è divenuto praticamente impossibile perché solo una forza superiore (cioè uno Stato separatista e protezionista) può recuperare il ritardo e sostenere le nuove, inesperte imprese nella lotta per la sopravvivenza che si svolge in un mercato già formato. D’altra parte la borghesia meridionale, sacrificata e repressa, ha ormai interiorizzato un complesso dell’impotenza, che è divenuto un aspetto saliente dell’intera società meridionale. Per giunta il vituperio civile ed economico che furono e sono, sin dal 1860, la sua connotazione particolare dentro la nazione italiana, l’inchioda all’impotenza.
Essa che non era tutta redditiera, tornò esclusivamente agricola e criptofeudale. Fondò il suo essere sociale sul possesso, che fu non sempre, ma spesso, possesso damnosus, fatto cioè di aride sterpaglie, di dirupi, di argille arse dal sole estivo e dilavate dalle piogge autunno-invernali. Comunque la prova del nove che la cosiddetta "questione meridionale" non dipendesse dalle classi dirigenti agrarie si è avuta quando, nonostante la loro scomparsa, i problemi del Sud sono rimasti nelle forme anteriori di sovrappopolazione e di quasi sterilità economica. Nel Meridione, una volta abrogato il maggiorasco (cioè la trasmissione di tutti i beni al figlio maggiore), la proprietà prese a frantumarsi. In passato, i cadetti ripiegavano sul sacerdozio, sul servizio militare, sulle attività di toga (avvocatura, magistratura). Con l’impoverimento delle rendite e la loro suddivisione, le entrate decaddero e i rampolli delle famiglie nobili e borghesi furono indotti a crearsi nuove entrate. Non avendo capitali a disposizione (sul problema del drenaggio dei capitali si vedano Nitti, "Nord e Sud", e Capecelatro e Carlo, "Contro la questione meridionale"), ripiegarono sulle professioni libere e sull’impiego. Relativamente a quest’ultima attività, la creazione di uno Stato a direzione centralizzata e con numerosa burocrazia periferica si deve dire che fu, a partire dal principio del secolo, la valvola di sfogo per tenere i ceti superiori del Meridione dentro il sistema italiano e per stroncare vocazioni separatiste e neoborboniche.
5 La storiografia di orientamento gramsciano sostiene che, attraverso l’alleanza tra gruppi industriali del Nord e grandi proprietà produttive di grano del Sud si realizzò il blocco conservatore, anzi reazionario che guidò l’Italia fino all’avvento del fascismo. C’è da osservare che Gramsci salta a piè pari circa quarant’anni di storia, perché il blocco di cui parla si realizzò in Parlamento soltanto nel 1887, quando il Meridione nel suo complesso era già stato sconfitto sul piano finanziario e geopolitico. Quanto all’età giolittiana in cui visse, Gramsci capì perfettamente che l’industrialismo "spontaneo" era già stato preparato politicamente con il protezionismo e finanziariamente con la concentrazione in poche mani delle risorse finanziarie. Capì anche che la proprietà fondiaria meridionale, sin dal principio, si era votata a Vittorio Emanuele per difendersi da una rivoluzione i cui prodromi erano nel brigantaggio sociale, e che fu proprio l’Unità ad impedirla, perché i Savoia avevano alle spalle forze moderate settentrionali a proteggerli nell’azione di repressione contadina aggiungiamo noi: cosa che invece i Borbone avrebbero avuta. Fu poi nei primi trent’anni di Unità che nacque il razzismo settentrionale che tanto peso avrebbe avuto nelle epoche successive e che rimane una delle questioni fondamentali della vita nazionale, oramai superabile soltanto con il superamento del sottosviluppo.
6 Zitara, L’unità d’Italia, op. cit.
7 Tarrow, Partito comunista e contadini nel Mezzogiorno, Einaudi, 1973.
8 INSOR (Istituto Nazionale di Sociologia Rurale), La riforma fondiaria: trent’anni dopo. Appendice statistica e bibliografica, Franco Angeli, 1979.
9 Ferrari Bravo e Serafini, Operai e stato, Feltrinelli, 1977.
10 Mi spiego con un esempio. Io ho il diploma di direttore d’orchestra e sono anche deputato, ma non trovo il mestiere di deputato adeguato alle mie ambizioni. Se nella cosca conto tanto da poter porre il veto a chiunque, in relazione alla carica di ministro degli Interni, posso facilmente ottenere la direzione del traffico aereo nazionale, che dà un cachet di un miliarduccio l’anno. Se poi mi capita anche d’avere un buon contatto con la Fabbrica Italiana di Locomotive, non ci penso due volte, e attrezzo l’aviazione di binari ed elettrotreni.
Quanto sopra (mafia bianca) è assai diverso dal caso (clientelismo volgare) di un mio collega che, stufatosi di ripetere ogni anno le stesse nozioni ai suoi alunni, un bel giorno mi annunziò: "Me ne vado a Roma, all’università". E io dico: "Ma non ti sembra un po’ tardi per un’altra laurea?". E lui a me: "Oh pezzo di fesso, vado ad insegnare, non a fare lo studente". Ero esterrefatto, credevo a uno scherzo. "Oh pezzo di fesso, è più facile di quanto credi, basta sapere quello che vuoi".
Un preside socialista, che chiede una supplenza per la figlia insegnante di tessera democristiana, si rivolge all’amico giusto del provveditorato che è comunista (caso del superpartito). Questi imbroglia un po’ le carte, scombussola un po’ i numeri e alla fine porta al provveditore una nomina già compilata per la firma. La giovane insegnante ha la supplenza. I ricorsi di coloro che sono rimasti fuori vengono insabbiati da un terzo amico repubblicano. Qualche tempo dopo, l’amico comunista ottiene dal provveditore cinque giorni di trasferta per ispezionare un distretto. Quattro li trascorre a casa. Il quinto giorno si reca alla sede stabilita. Intanto il preside socialista ha già preparato una breve relazione. L’amico arriva, distribuisce in mezz’ora cinquanta firme, si becca la relazione e torna dalla missione in provveditorato.
Fonte:Rivistaindipendenza
-







.jpg)